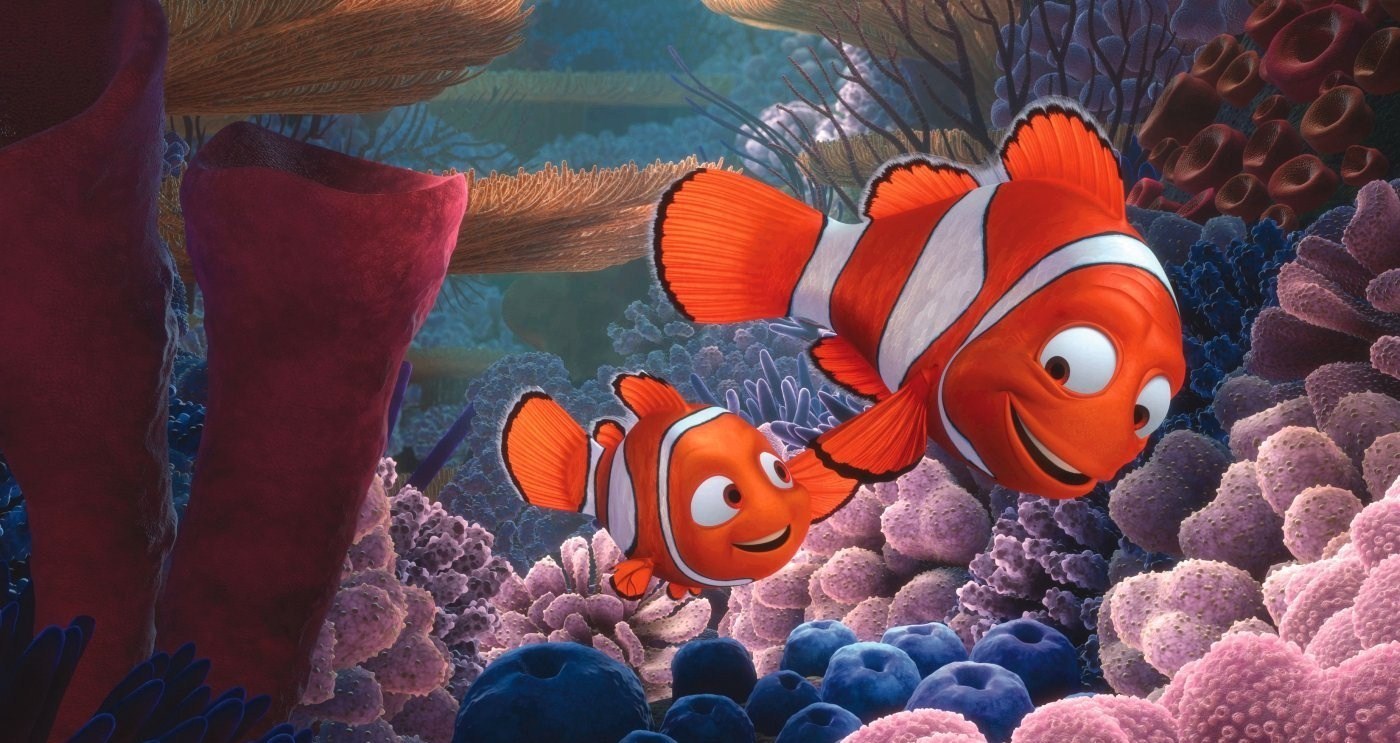Nel nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, tre amici attraversano quarant’anni di storia italiana: si conoscono nel 1982, a 16 anni, e continuano a intrecciare le loro vite nei successivi 40, facendo scelte sentimentali e lavorative diverse. Con loro (e tra loro) c’è anche una ragazza, Gemma, la fiamma che accende desideri e aspirazioni, che prima unisce e poi strappa il gruppo. Ci sono tracce evidenti della grande commedia all’italiana, quella di Ettore Scola e Dino Risi, ma la sensibilità per il melodramma del regista di L’ultimo bacio resta peculiare e inconfondibile. Nei ruoli principali tornano due grandi attori “mucciniani” come Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria, assieme a Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart, che portano nel film il loro particolare talento nel mettere in scena le fragilità del cuore, venando il dramma di un paradossale umorismo. I loro volti ringiovaniscono e poi invecchiano grazie a un uso del digitale che subito richiama alle mente le emozioni e le riflessioni suscitate da The Irishman. Incontriamo Gabriele Muccino pochi minuti dopo aver visto una versione quasi definitiva del film, con l’epilogo cambiato al montaggio proprio negli ultimi giorni.
Abbiamo appena finito di parlare di de-aging per il film di Scorsese, trovo molto interessante che un film italiano si sia cimentato quasi contemporaneamente con la stessa cosa. Diciamo che qui gli attori sono ringiovaniti di 20 anni e non di 40, ma il risultato finale è più realistico.
«Beh, sai, era un fatto dettato dalla sceneggiatura, perché il cast che mi permetteva di realizzare questo film come lo volevo non era un cast di trentenni. Il trentenne con il trucco lo puoi trasformare sia in un ventenne che in un cinquantenne, ma il cinquantenne o il quarantenne non lo puoi ringiovanire fino a essere un laureando con il solo make up. È proprio la laurea che stringe radicalmente i tempi… Non erano sequenze che potevamo girare con facce da trentacinquenni, sarebbe stato straniante. Abbiamo pensato a come fare, ho iniziato a parlarne con degli amici esperti in CGI e ho scoperto che esistevano dei software, sempre più aggiornati – l’ultimo dei quali è uscito lo scorso anno ed è stato anche elaborato, ovvero ha subito una rivisitazione tutta italiana – per cui diventa un sistema molto simile a quello utilizzato da Scorsese ma diverso, perché scansiona il volto e l’espressione degli attori e poi riesce a rimodellare il viso e a restituirlo senza che tu sostanzialmente te ne accorga. Il fatto è che ci credi, li vedi invecchiare davanti ai tuoi occhi nel corso di una storia che diventa sempre più impattante, perché la vita in pratica gli scorre addosso in due ore o poco più. Credo sia proprio una delle componenti forti del film, il fatto che tu realizzi che la tua vita è veloce, che dai vent’anni fino alla vecchiaia è un attimo».

Questa è anche una novità, nel senso che tu sei un autore celebrato per le tue “istantanee”, per come sai isolare e fotografare in un film un determinato momento, con certe persone in una certa situazione.
«La grande differenza tra questo film e i miei precedenti credo che sia proprio quella di aver messo al centro non l’individuo nevrotico o l’individuo sotto stress, che agisce quindi di conseguenza, ma di aver scelto come motore dell’intera vicenda il tempo. Il tempo è il grande burattinaio che modella i personaggi creando il loro destino, perché propone continuamente delle situazioni impreviste, e gli imprevisti impongono delle scelte. È il timing con cui arrivano che ci dà l’opportunità di aprire una porta invece che un’altra».
Quand’è che hai sentito che volevi introdurre questo elemento? Come è nata dentro di te questa esigenza?
«Forse col tempo, con i film che ho fatto, pian piano ho pensato a quanto la vita può essere difficile. Ho ripensato a C’eravamo tanto amati e a questi film che in qualche modo raccontano proprio il passare degli anni, e come cambiamo».
Un’altra cosa che caratterizza molto il tuo cinema è il modo in cui dirigi gli attori. Inconfondibile. Cioè, se uno guarda un tuo film, anche senza sapere che è tuo, bastano due minuti e lo capisce subito. Per come si muovono, per come li riprendi. Quindi volevo chiederti come lavori sull’energia degli attori, sia quando devono trattenerla, sia quando devono liberarla…
«Il lavoro del regista non consiste nel fare un’opera buona, è simile invece a quello del direttore d’orchestra, che trattiene e rilascia, che comprime e dilata. Richiede una forte leadership, perché gli attori hanno sempre bisogno di un comandante che, come un direttore d’orchestra, detti i tempi sul set. Questa è una dote naturale che mi sono ritrovato, perché è difficile insegnarla o trasmetterla, e sostanzialmente fa di me il regista che poi sono diventato. Ho scoperto col tempo che mi emozionavo solo quando gli attori si emozionavano sulla scena. È successo già col primo film ma è da Come te nessuno mai che ho iniziato a sentire questa necessità: prendere attori veri, non impostati dalle scuole di recitazione, che attraverso il loro realismo e la loro emotività mi emozionavano davanti al monitor in fase di ripresa. Questa corrispondenza tra me e l’attore poi si è sviluppata. Ho imparato a capire che cosa poteva essere migliorato e come. Perché ci sono attori che migliorano se tu li fai sentire inadeguati e invece attori che si paralizzano se gli dici che sono inadeguati. Attori che vanno coccolati, altri che vanno rassicurati, eccetera. Ma la cosa più importante di tutte è che gli attori perdano il controllo di quello che stanno facendo. Perché se l’attore ha un piano in testa per la scena, quel piano lo porta già in una zona di deragliamento per quello che è il mio cinema».

Che metodo usi per portarli dove vuoi?
«Scelgo attori molto talentuosi, poi proviamo assieme tutto il film per settimane prima di girare… Per raffinare i dialoghi, per capire il ritmo della scena, per permettere loro di conoscersi e creare una certa chimica, così che quando arrivano sul set è già esplorata. Io stesso capisco come possono svilupparsi i personaggi rispetto a come li ho scritti, le battute che funzionano meglio e quelle che devo aggiustare. È un processo lungo. Con Will Smith ci siamo seduti per 5 settimane a fare questo lavoro e abbiamo riscritto interamente entrambi i film (La ricerca della felicità e Sette anime, Ndr), la sceneggiatura diventa un lavoro di work in progress. Con i miei film italiani la sceneggiatura era già molto solida, mentre in quelli americani molto meno».
Quindi hai usato lo stesso metodo anche in America.
«Sì, cambia profondamente la macchina industriale ma se sai scrivere e conosci i meccanismi primari della messa in scena della vita, queste due cose non cambiano. Il cinema è quello, si fa così. Gli attori sono simili, l’anglosassone è agevolato da una lingua più scivolosa, mentre noi siamo facilitati dai nostri regionalismi dialettali. All’attore che parla romano, napoletano, barese diventa impossibile imporre una lingua neutra, perché nella vita non succede mai di sentire qualcuno parlare in un italiano tutto impostato, rovinerebbe la perfomance. Questa è una lezione che si impara guardando i film di De Sica e tutto il cinema che è venuto dopo, che poi ha innaffiato il cinema degli anni ’70 americano».

Che è venuto dopo fino a quando?
«È un cinema che parte con Vittorio De Sica e finisce più o meno con Sergio Leone all’inizio degli anni ’70. Gli ultimi film importanti sono di quel periodo, anche se C’era una volta in America è del 1984. Poi inizia un arroccamento degli intellettuali che ha ideologizzato tutto, incluso il cinema, che a quel punto smette di essere una forma di comunicazione popolare, come era sempre stato e come dev’essere. Il cinema è prima di tutto intrattenimento e deve continuare a fare quello, perché se non intrattieni fondamentalmente non esisti. E anche quando parliamo del pubblico di nicchia e di film d’essai, molto piccoli, l’intrattenimento è necessario. Altrimenti diventa una celebrazione sterile, cose che non restano nel tempo. I film di Kubrick ci hanno formato perché emotivamente e narrativamente erano popolari, così come il cinema di Fellini, di De Sica, di Woody Allen… Kramer contro Kramer…».
Nel provare a rifare un certo cinema non ideologizzato ma che invece sia popolare in modo intelligente, credi che gli americani siano più avanti di noi? Hai citato Kramer contro Kramer, ed è uscito di recente A Marriage Story…
«Si hai ragione, è la rielaborazione contemporanea dello stesso tema».

…poi c’è Joker che riprende i film di Scorsese degli anni ’70, Scorsese che rifà se stesso con The Irishman, Woody Allen che torna a Manatthan…
«Però, ecco, Scorsese… L’imbastardimento di Joker, che è preso da Re per una notte, ma alla fine deve accontentare la DC, secondo me è un grosso limite. Perché alla fine rimani spaesato e ti chiedi: “Ma che mi stai raccontando, Joker o uno psicopatico qualunque?” E alla fine devi trovare un compromesso. E questo non succede in Re per una notte».
Beh, Re per una notte è proprio di un altro livello.
«Quello che voglio dire è che se in Joker avessero avuto il coraggio di essere essenziali come in Re per una notte probabilmente sarebbe stato qualcosa di molto più potente. E in America oggi non hanno coraggio. Perché Netflix ha depredato tutto il pubblico di qualità, portandolo sui suoi schermi. Io ho avuto la fortuna di fare alcuni degli ultimi film drammatici che i grandi Studios erano disposti a fare, sei o sette anni fa erano progetti ricercati. Oggi è impensabile che una major come la Columbia di quel tipo torni a fare film come quelli, Netflix e Amazon si sono presi quella nicchia. Adesso fanno Mary Poppins. Ma perché non sanno più a chi parlare, hanno un periodo di crisi paragonabile a quello del passaggio dal cinema muto a quello sonoro».
Allora colgo lo spunto per andare sul tema della serialità. C’è chi ritiene che un certo tipo di scrittura, di cura dei personaggi e di libertà creativa si sia trasferita lì…
«La serialità ma anche la formula del film unico come Storia di un matrimonio o Roma. Cioè quello lì è il futuro, laddove non c’è più la possibilità di fare film che possano creare un grosso evento. Perché ormai il cinema è fatto da eventi, eventi che creano attorno al film un’attenzione forte. Altrimenti il film non esiste. Sulle piattaforme digitali non hai l’ansia dell’incasso del primo weekend, hai solo la necessità di fare un prodotto di qualità, che crescerà molto probabilmente col tempo. Però non stanno rovinando il cinema, lo stanno solamente portando altrove».

Restando al tema della serialità: Frémaux, direttore del Festival di Cannes, due anni fa disse: “Io evito di selezionare le serie Tv, tranne poche eccezioni, perché le serie Tv sono industria mentre il cinema è arte”. Volevo sapere com’è il tuo rapporto con la serialità, cosa guardi e se ti piacerebbe fare lo showrunner.
«Un’idea per una serie la sto elaborando ma è davvero troppo presto per parlarne, cannibalizzerebbe il film. L’idea in generale è interessante, meno l’idea di entrare in una serie come regista per qualche episodio, come fanno in America: sei sottopagato e devi di fatto clonare lo stile del regista del pilot, è molto frustrante. Lì concordo che di artistico non esiste nulla. C’è solo la presentazione “grammaticale” di un lavoro che, se ben scritto e ben interpretato, diventa una bella serie o altrimenti qualcosa di dimenticabile. Però quello che la crea è chi la scrive e chi l’ha ideata, inclusa la scelta del cast e dei registi che devono portarla avanti con coerenza stilistica. Affidarla a registi che si alternano significa anche non dare troppa priorità al regista, perché è lo showrunner la vera mente dietro al tutto e deve mantenere il potere. Quindi non è molto eccitante come soluzione, a meno che non ti venga chiesto di dirigerla interamente come fa Lynch. Se dirigi tutto è un grande romanzo, come il Pinocchio di Comencini, che resta per decadi. Poi ci sono comunque serie che mi hanno molto emozionato, di grande impatto».
Per esempio?
«La prima serie che mi ha impressionato, quella che mi ha fatto capire che il linguaggio e il territorio a cui ci saremmo dovuti rivolgere in futuro stavano radicalmente cambiando, è stata Breaking Bad. Era scritta in modo favoloso e diretta benissimo, anche se i registi erano diversi. Quella mi è rimasta. Poi House of Cards è stata importantissima, perché ha sdoganato definitivamente il fatto che gli attori che facevano la Tv non fossero solo di serie B, oppure ex star. Era come dire: “Non viene più prima il cinema e poi la Tv. Ci sono il cinema e la Tv”. E poi altri casi ancora come Narcos, in cui si parlano due lingue e che quindi ha sdoganato il sottotitolo».

Tornando al film… Le canzoni di Baglioni hanno un ruolo importante. Oltre a Mille giorni di te e di me e a E tu come stai?, mi ha colpito la canzone nuova che si ascolta sui titoli di coda: non l’avevo mai sentita ma era come se la conoscessi.
«Si perché è un Baglioni anni ’70 e ’80, perfetto per il film. Me l’ha proposta e quando l’ho sentita ho deciso anche di cambiare il titolo del film: è stata una coincidenza strana e assoluta. Ero andato da lui a cena a chiedergli di darmi a un prezzo accettabile quelle due canzoni che citavi, perché Baglioni rappresenta in maniera fortissima gli italiani che si sono innamorati durante questi ultimi 50 anni. Magari a scuola dicevi che ascoltavi De Andrè, ed era anche vero… ascoltavi i Clash, ascoltavi De Gregori. Ma quando stavi da solo a casa poi mettevi Baglioni. Ti innamoravi e cantavi Baglioni… Ma quello non si poteva dire. Quindi è anche un omaggio a quella cultura popolare che, come dicevo per i film di Scola, Fellini e Sergio Leone, poi fu disinnescata come fosse una miccia pericolosa dall’ideologia degli anni ’70, con il cinema che iniziò ad agonizzare per poi andare a morire. È accaduto anche nella musica».
Nel film i protagonisti hanno 16 anni nell’82. Tu che età avevi all’epoca?
«Uguale, la stessa».

Quindi se uno ti dice che il tuo è un cinema generazionale ti riconosci in questa etichetta?
«Io l’ho sempre sentita come una limitazione, perché quando si va avanti con gli anni non è l’età che ci cambia, è il tempo. È normale a 30 anni pensare che il quarantenne sia vecchio, poi a 40 pensi che il cinquantenne sia vecchio… La vita ci inganna su tutti i fronti. Però da quando uscì L’ultimo bacio è nata questa terminologia che etichettava le storie in quanto legate a un’età».
Diciamo che se avessi fatto tutti i film in costume ambientati a inizio secolo nessuno si sarebbe sognato di dirti una cosa del genere ma tu sei per me, che sono un cinefilo, fortemente associato a una certa generazione di attori, a un certo modo di ripensare la grande commedia all’italiana riportandola alla contemporaneità. Così questo film mi sembra come la chiusura di un cerchio, perché tornano parte di quegli attori con cui hai lavorato in passato e attraversano la vita con gli stessi anni che tu avevi nelle varie epoche.
«Allora accetterò questa cosa (ride). Se parliamo di uomini e donne attraverso il tempo è più che pertinente. Perché parto da lì, non sono mai racconti legati a una generazione. Ad esempio, in questo film è ovvio che lo sguardo di Gemma sul mondo sia enormemente metamorfico. La Gemma cinquantenne è diversissima da quella più giovane della fontana di Trevi, che invece è tesa, incompiuta, irrisolta. E anche da quella poco più che ventenne che tradisce e non sa nemmeno perché, non sa cosa vuole. O da quella adolescente con la madre malata. La vita sembra chiamarti per darti cose migliori, però ti inganna».

Che rapporto hai coi ragazzi di oggi, con le nuove generazioni? Come ti immagini le reazioni di un giovane di oggi che vede questo film?
«I giovani, o gli adolescenti che vivono là fuori nel mondo, li conosco molto poco. Ma li intercetto attraverso i miei figli, che hanno 20, 13 e 10 anni. Quindi ho la possibilità di tenere i piedi ben piantati su quello che succede. Ed è necessario, perché la paura di invecchiare nel punto di vista delle cose è un problema. Il rapporto con la realtà è fondamentale e me lo vado a cercare. Non sto in casa a rimuginare: cerco ad esempio di frequentare certe zone della città, una cosa che in America non potevo fare perché rischi una brutta fine, nei ghetti ti sparano. Invece qui vado in giro, ascolto storie, osservo la gente e questo è una grande ispirazione».
Riesci ancora a farlo con una certa libertà? Sorrentino durante un’intervista di qualche settimana fa mi diceva che lui prima quando andava nei ristoranti osservava la gente, adesso sono gli altri che osservano lui.
«Ma se vuoi osservi eccome, le esperienze devi viverle. Devi guardare, stare con la gente vera e allora ne senti di storie, vedi come è la vita. Il problema che ha avuto ad esempio Scola, come mi hanno riferito dei suoi amici e colleghi, è stato che quando ha smesso di prendere il tram si è allontanato dalla realtà. E questo allontanamento è un po’ il tunnel dell’artista. Bisogna continuare a prendere il tram a guardare la gente per capire come si evolve, cosa fa, perché vive le cose in un modo piuttosto che in un altro. Il regista deve cercare di reinventarsi ogni volta una nuova giovinezza, anche se illusoria. Raccontare i “pischelli” degli anni 80 in quest’ultimo film mi ha costretto a tornare a quell’epoca, a tornare al Piper di Roma, a certi sogni “analogici”, alle urla da cortile… Tutto quel mondo l’ho dovuto riscoprire e l’ho trovato così mio che è stato una grande emozione».

Per i ragazzi che interpretano quella prima parte del film ovviamente valeva l’opposto.
«Durante il film a un certo punto hanno staccato i telefoni per capire cosa voleva dire essere “analogici”, per esempio il fatto di chiamare a casa di un amico: “Pronto c’è Francesco? Sa quando torna? No? Grazie signora”. Bum, fine. Le attese erano dettate dall’impossibilità di rintracciare qualcuno quando volevi tu e come volevi tu. Questa comunicazione di oggi, immediata e nevrotica, elimina proprio quel rapporto fisico. E non è un caso che le piazze oggi si riempiano di ombrelli o di slogan. Ora non so se queste cose si evolveranno, tradiranno se stesse, si smarriranno, però è un segnale. Il modo in cui Gretha Thunberg riesce a portare in piazza delle persone… La piazza è necessaria. Sta tornando importante come lo è sempre stata nella storia dell’uomo perché evidentemente il fatto di esserci è diverso dal fatto di socializzare a distanza. Quella sterilità la stiamo soffrendo e iniziamo a pagare il prezzo dell’illusione della modernizzazione. Io immagino che ci sarà un contraccolpo per cui le cose verrano rimodellate. Si comunicherà digitalmente per scopi diversi, e non in questo modo sregolato, senza limiti, senza codici, dicendo le cose più terribili nascondendosi dietro una tastiera».
Tra l’altro tu i social li usi con una certa serenità mi pare…
«Facebook in realtà è uno specchio del mio Instagram, ci passa quello che posto lì, altrimenti fosse per me lo cancellerei: non mi piace tutto l’”impiccio” che ci sta dietro, tutto quel marcio. E poi questo significato che si dà all’amicizia. Ma amicizia de che? L’amicizia è sacra. È stato un cambio che ha fatto deragliare il mondo, cha cambiato la percezione delle realtà in modo pericoloso. Ha portato a nuove forme di solitudine e di rabbia. Invece in piazza ti confronti, rendi fisica la tua esistenza e comunichi con una dialettica reale. Su Facebook ci sono solo commenti assurdi. Quindi al di là della necessità del marketing, del dover veicolare i film anche attraverso questo canale, non mi rimane molto. Più passa il tempo, più mi sembrano degli strumenti che si evolveranno in altro, mi auguro in qualcosa che sia più consono alla natura dell’uomo e al suo bisogno di comunicare veramente chi è. E non di simulare un’identità per prendere dei like».
Foto: © Andrea Miconi/Courtesy of 01 Distribution
© RIPRODUZIONE RISERVATA