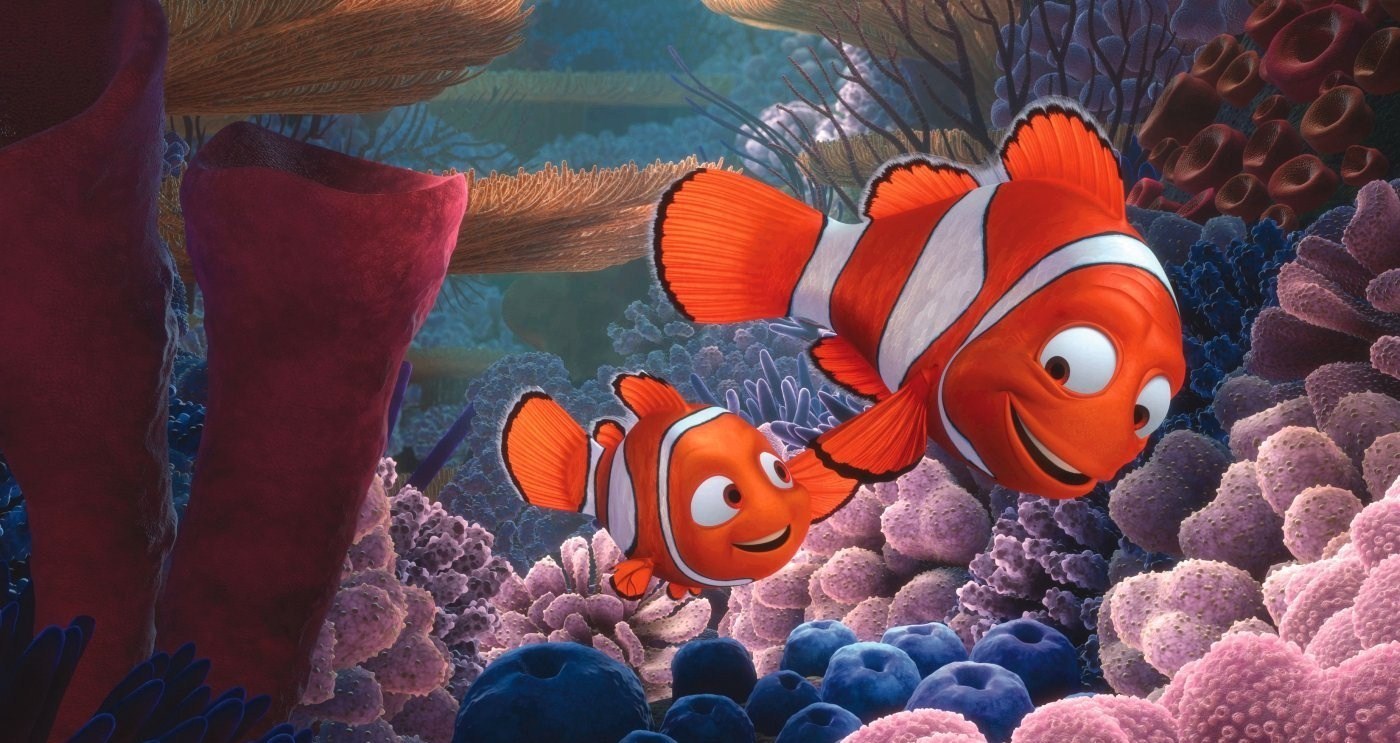Jojo (il piccolo e credibilissimo Roman Griffin Davis) ha dieci anni, vive a Vienna con la mamma (Scarlett Johansson) e ha un amico immaginario dispotico: Adolf Hitler. Nazista fanatico, col padre “al fronte” a boicottare il regime e la madre a casa a fare quello che può, è integrato nella gioventù hitleriana. Tra un’esercitazione e un lancio di granata, Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa (Thomasin McKenzie), una ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato partigiano, Nathan.
Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere, lei per restare in vita, lui per proteggere sua madre che ama più di ogni altra cosa al mondo. Ma il condizionamento del ragazzo svanirà progressivamente con l’amore e un’amicizia più forte dell’odio razziale. Ha scelto questo soggetto peculiare, Taika Waititi, per prendersi una vacanza dalle grosse maestranze Marvel, che lo vedranno dietro la macchina da presa di Thor: Love and Thunder, e raccontare la vicenda di un bambino al tempo della Seconda Guerra Mondiale muovendo dal romanzo Caging Skies di Christine Leunens.
Jojo Rabbit è a tutti gli effetti una fiaba teen, ciò che sarebbe stato Moonrise Kingdom, e più in generale il cinema di Wes Anderson, se al suo interno la malinconica e ovattata tenerezza per i propri personaggi bidimensionali e il gusto per la caricatura a effetto fossero stati entrambi catapultati verso una parodia cartoonesca della Storia con la s maiuscola. Parlando dell’Olocausto in chiave leggera la tradizione in cui s’inserisce Waititi, regista e interprete dello stesso Adolf Hitler in un impeto di divertito e caustico ma mai fastidioso protagonismo, è piuttosto florida e gli esempi si sprecano, a partire da La vita è bella, tra l’altro esplicitamente citato da un gesto con le braccia della Johansson che replica il celebre movimento burattinesco di Benigni, fino a Train de Vie passando ovviamente per Il grande dittatore di Charlie Chaplin.
Rispetto a questi film, però, Jojo Rabbit non ha quel tipico saliscendi di risate e lacrime. Nella sua partitura di sketch e scenette sceglie di adottare quasi esclusivamente una sola nota, quella del romanzo di formazione d’epoca con incorporata storia d’amore per ragazzi. Il sottofondo, costante, è invece scandito dalla rivisitazione fumettistica della Shoah: un approccio solare e scanzonato che non rinnega il dramma, che quando affiora sa come lasciare i suoi strascichi, ma che preclude alla narrazione molte possibilità, non riservando deviazioni e sorprese rispetto al tracciato di base.
In virtù di quest’anima molto precisa, assai in linea col piglio sornione di un personaggio gioiosamente infantile e liberissimo come Waititi, Jojo Rabbit regala però più di un momento ispirato e sinceramente divertente. Dalle sequenze con in scena Hitler, che cita Jesse Owens e Winston Churchill (alcune battute sono davvero esilaranti), al prologo con addestramento militare e messa alla berlina del saluto nazista, «Heil Hitler!», talmente reiterato da essere svuotato di senso, come vecchio e reiterato meccanismo comico impone. Un processo di demistificazione che investe tutto il film, con un certo coraggio anche quando mancano il graffio e la zampata corrosivi e a trionfare è la bontà didattica.
A Waititi, infatti, più che l’ulteriore denuncia dell’orrore perpetrato a suo tempo, sembra interessare l’esigenza di sfumare di tenerissimo romanticismo e occasionale poesia la sua vena al contempo stramba e pirotecnica, che aveva già trovato sfogo nella follia vampiresca del mockumentary What We Do in the Shadows e nel furore caotico e sghignazzante di Thor: Ragnarok.
Una cifra, quella all’insegna del mantra «è buffo perché è vero», che invade ogni dettaglio, dai personaggi alle divise, dalle scenografie alle canzoni, quelle dei Beatles e Heroes di David Bowie. Il macchiettismo si ritrova così a coabitare con la fanciullezza e le sue ingenuità («Tu non sei nazista, ma sei solo un bambino di dieci anni che ha bisogno di sentirsi parte di un club») e il risultato finale, in questo senso, non difetta affatto di piacevolezza, fino a farsi un’ode esile ma sincera alla sopravvivenza del candore in un deserto di macerie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA