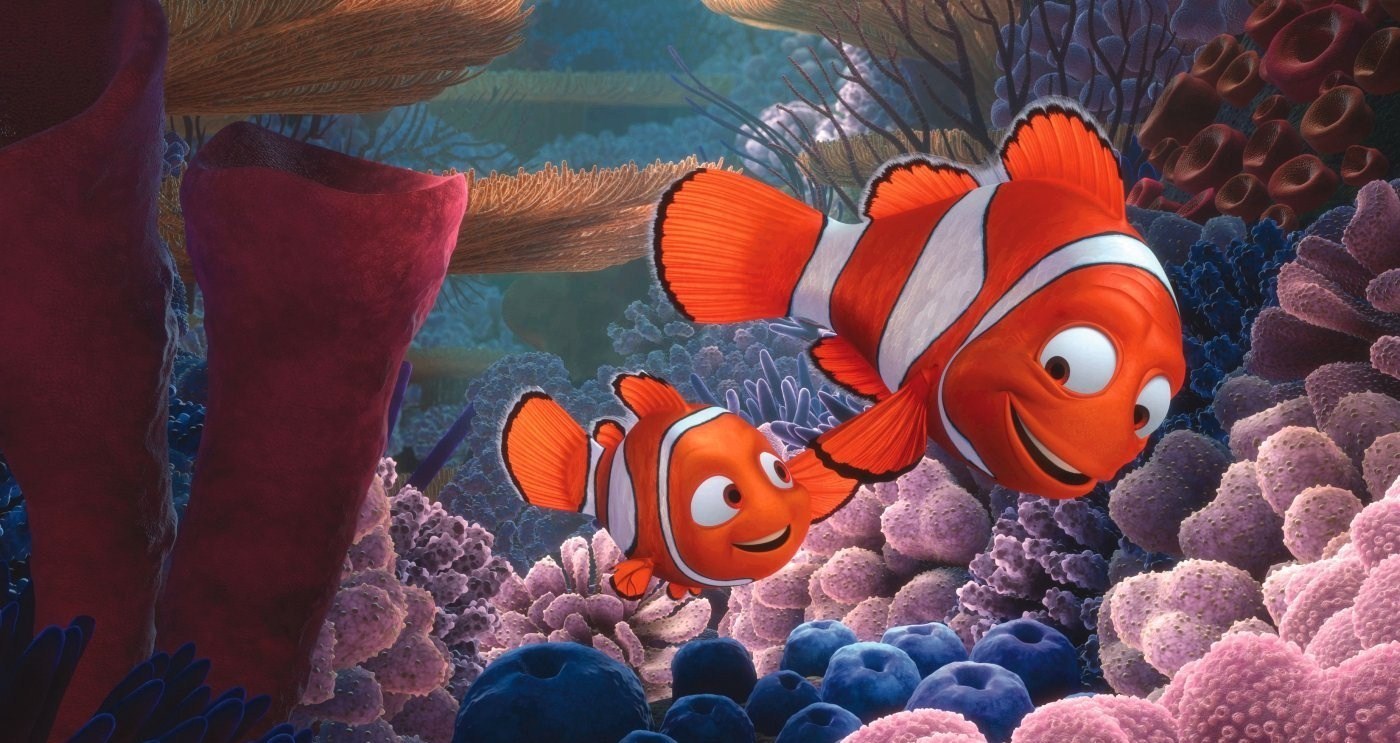In questi giorni, per questioni riguardanti il mio altro lavoro (quello in cui scrivo fumetti), ho riguardato più volte la sequenza iniziale di Apocalypse Now e la cosa mi ha spinto a una riflessione sul linguaggio cinematografico moderno. Quindi, questo mese, divaghiamo. E lo facciamo partendo da lontano, dal finire degli anni ’50 del secolo scorso. In quel periodo la macchina degli studios hollywoodiani sta passando un momento complicato. La televisione è entrata in tutte le case d’America e il mondo del cinema, se da una parte sta facendo soldi rivendendo vecchi film ai network televisivi, dall’altra è in un momento di forte perdita d’identità.
Come si può far capire agli spettatori che il cinema è qualcosa di più rispetto allo spettacolo televisivo? E poi, dimensioni dello schermo a parte, lo è davvero? In quel periodo il cinema USA ha codificato e perfezionato una metodologia produttiva (e, di conseguenza, una grammatica artistica) che garantisce fattibilità e fruibilità.
In sostanza, seguendo “il metodo” passo per passo, ideare, realizzare e mandare in sala un prodotto di intrattenimento dignitoso è, relativamente, alla portata di tutti. I grandi maestri dell’epoca (che sono davvero grandi, sia chiaro) operano perlopiù all’interno dei paradigmi stabiliti, limitandosi a perfezionarli o a portare piccole innovazioni all’interno della tradizione (che vengono poi rapidamente assorbite, diventando esse stesse parte del “metodo”).
Tra le produzioni cinematografiche e quelle televisive il metodo di produzione e linguaggio è, sostanzialmente, uniforme ed è complesso far capire al pubblico perché un film e un serial della Tv sono, in realtà, due cose diverse. Bisogna reinventare tutto. E a farlo non sono gli americani ma i francesi. Prima Truffaut e poi, soprattutto, Godard che, nel 1960, realizza quel capolavoro eversivo di Fino all’ultimo respiro. Il film prende le mosse dal cinema americano che Godard ama di più, quello del crime e dell’hard boiled, e sembra volerlo omaggiare. Non fosse che, invece, ne opera un sostanziale stravolgimento.
Godard arriva sul set praticamente senza sceneggiatura e gira giorno per giorno all’impronta, inventa nuovi angoli di ripresa, trascura quello su cui il cinema americano di maniera si sarebbe concentrato (gli omicidi e le azioni spettacolari o i momenti di tensione, per esempio), per soffermarsi sul non necessario allo sviluppo della trama (le lunghe chiacchierate in albergo tra i personaggi). Ne esce fuori un film ancora oggi freschissimo e inedito.
Non piani cabile a tavolino e, soprattutto, non replicabile. La lezione della Nouvelle Vague è accolta, inizialmente, con forte ostilità e diffidenza ma, con l’esplosione della controcultura, non sono pochi i registi statunitensi che ne fanno tesoro, facendo propri non gli stilemi ma l’approccio.
Nasce così un nuovo cinema a stelle e strisce, più anarchico, imprevedibile e fresco. E, produttivamente e commercialmente, molto più rischioso. Perché uno script solido o un preciso piano di lavorazione non sono più una garanzia, visto che i film non vengono più definiti in fase di scrittura o produzione ma, spesso, direttamente sul set o ancora dopo, in fase di montaggio.
E veniamo alla sequenza iniziale di Apocalypse Now, film del 1979 di Francis Ford Coppola. La pellicola si apre sulla giungla vietnamita con gli elicotteri Huey americani che la sorvolano, sganciando fumogeni e napalm, mentre nell’aria risuonano le note dei Doors (1).

Il volto capovolto di Martin Sheen si fonde alle immagini, prima della giungla (2)

poi di una grande statua (3).
 Ancora fiamme, ancora elicotteri, ancora giungla. Poi si torna su Sheen mentre la camera ruota. Scendiamo (4).
Ancora fiamme, ancora elicotteri, ancora giungla. Poi si torna su Sheen mentre la camera ruota. Scendiamo (4).
 Carrellata sugli oggetti che compongono il passato, il presente e il futuro del protagonista, le sue ossessioni, le sue dipendenze, il suo lavoro (5).
Carrellata sugli oggetti che compongono il passato, il presente e il futuro del protagonista, le sue ossessioni, le sue dipendenze, il suo lavoro (5).
 Le pale degli elicotteri diventano la pala del ventilatore di una stanza d’albergo. Sheen si alza, guarda il Vietnam dalla nestra. «Saigon, merda. Sono ancora soltanto a Saigon». Riprende il delirio e sale la disperazione (6).
Le pale degli elicotteri diventano la pala del ventilatore di una stanza d’albergo. Sheen si alza, guarda il Vietnam dalla nestra. «Saigon, merda. Sono ancora soltanto a Saigon». Riprende il delirio e sale la disperazione (6).

Il nostro protagonista si agita nella stanza, mimando mosse di arti marziali (7)

mentre in, sovrimpressione, lo vediamo mentre esce da sotto l’acqua di una palude, con il volto coperto da una tinta mimetica (8).
 Attraverso le immagini, in un andirivieni di flashback e flashforward, Coppola ci racconta il senso del protagonista per una tragedia immanente e inevitabile. Poi, inizia davvero il film. Questa prima sequenza di Apocalypse Now è impossibile da scrivere o prevedere. È una scena che nasce in fase di montaggio, con tutto il girato del film a propria disposizione e la libertà di poterlo usare liberamente, sfruttando l’ispirazione del momento. Non è una sequenza realmente pianificabile o definibile, non è nemmeno raccontabile ai produttori che dovranno mettere i soldi per il film. È qualcosa che nasce nel film, facendolo e, per questo, del tutto imprevedibile.
Attraverso le immagini, in un andirivieni di flashback e flashforward, Coppola ci racconta il senso del protagonista per una tragedia immanente e inevitabile. Poi, inizia davvero il film. Questa prima sequenza di Apocalypse Now è impossibile da scrivere o prevedere. È una scena che nasce in fase di montaggio, con tutto il girato del film a propria disposizione e la libertà di poterlo usare liberamente, sfruttando l’ispirazione del momento. Non è una sequenza realmente pianificabile o definibile, non è nemmeno raccontabile ai produttori che dovranno mettere i soldi per il film. È qualcosa che nasce nel film, facendolo e, per questo, del tutto imprevedibile.
E veniamo a oggi, in questi quasi anni ’20, con il cinema di nuovo in crisi e minacciato dalla televisione (on demand, questa volta). Un’epoca dominata dal “metodo” Marvel Studios e dai suoi film. Prodotti pensati e pianificati a tavolino secondo un sistema ormai rodato e raffinatissimo, capace di portare a casa un “prodotto medio” sempre dignitoso e mai fuori budget. Film che non lasciano alcuno spazio all’improvvisazione e che fanno della prevedibilità del loro linguaggio il loro punto di forza.
C’è davvero differenza, a parte i mezzi a disposizione, tra una di queste pellicole e la puntata di una serie televisiva qualsiasi? Io faccio fatica a vederla. E me ne sto qui, ad aspettare una nuova apocalisse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA