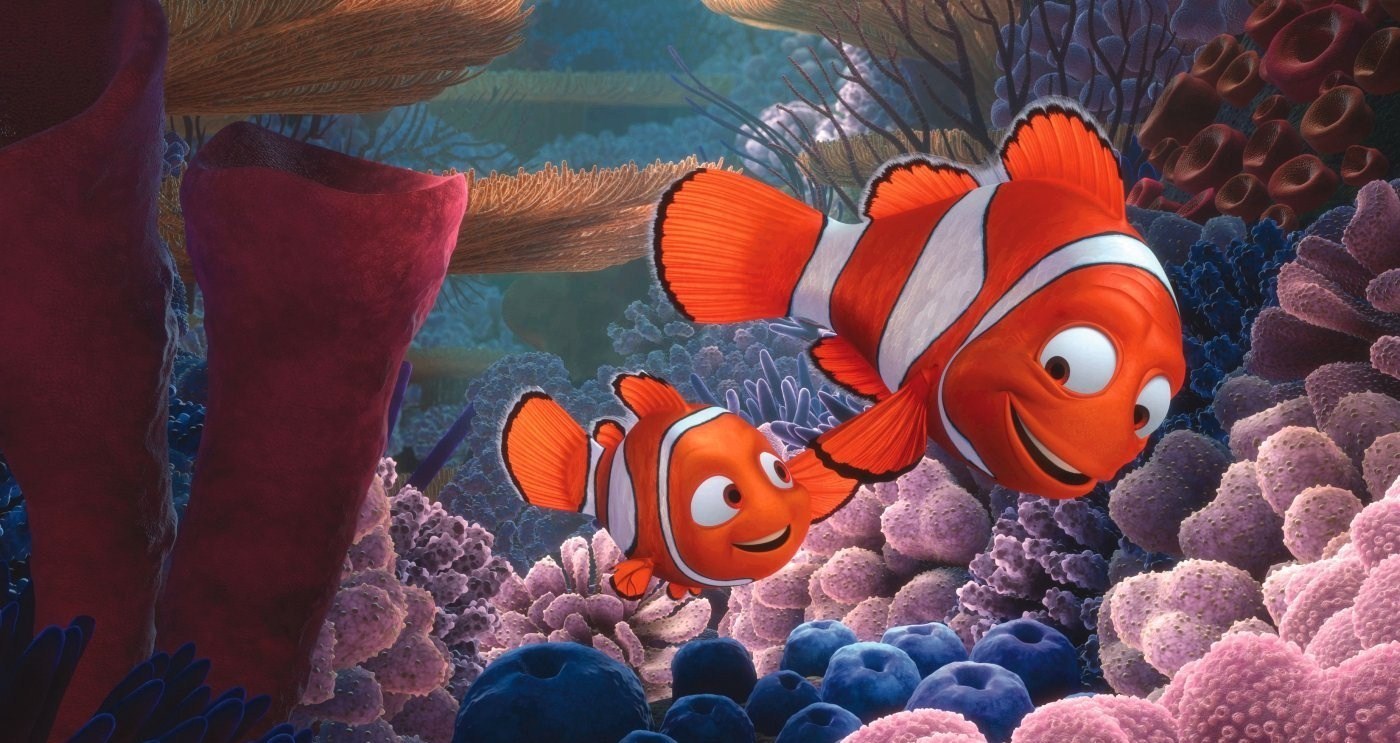The Revolution Will Be Televised…on movie screens.
La rivoluzione passerà dalla televisione, ma verrà legittimata dagli schermi del cinema. Da un punto di vista istituzionale è quello che sta accadendo alle ibridazioni sempre più forti tra grande e piccolo schermo. Almeno parlando per metafore o per vecchie nomenclature. Se da una parte il sistema dei media deve infatti fare i conti con una espansione delle abitudini di fruizione su una molteplicità di schermi e di supporti, in cui la funzione del mezzo non serve più a veicolare il messaggio specifico (su quanti e quali schermi guardiamo le serie tv o i film?), dall’altra parte, il sistema stesso affronta la rivoluzione in atto affidandosi alle distinzioni canoniche tra media, dove il cinema è opposto alla televisione.
Una questione di status o di geopolitica più che una questione di geografia, là dove, a tutti gli effetti, tra grande e piccolo schermo la spartizione delle aree di influenza è ormai soffusa e scontornata. Prendiamo alcuni esempi, per fare chiarezza.
La Berlinale ha annunciato stamattina che, per la 65esima edizione della mostra, viene confermata la sezione Berlin Special Series, dedicata alla presentazione in anteprima di alcune delle serie più promettenti della scena mondiale.
Tra questi otto lavori, provenienti da Germania, Svezia, Stati Uniti e Israele, spiccano senza dubbio lo spin-off di Breaking Bad Better Call Saul, scritto e diretto da Vince Gilligan (di cui già la critica americana ha scritto le prime recensioni) e il “nostro” 1992, fiction con Stefano Accorsi che racconta, tra politica e inchieste, lo scandalo di Tangentopoli per la regia di Giuseppe Gagliardi.
La notizia conferma il peso sempre maggiore della narrazione seriale e delle sue interazioni con il grande schermo, soprattutto se contestualizzata alla luce di altre notizie, apparentemente slegate tra loro ma che, messe in fila, inquadrano una rivoluzione di sistema. L’annuncio che alcuni episodi della quarta stagione di Game of Thrones saranno mostrati in America sugli schermi IMAX insieme alla partecipazione di un maestro fino a questo momento inscindibile dalla narrazione cinematografica come Woody Allen a una serie tv commissionata da Amazon, sono segnali che indicano chiaramente un percorso ibrido, che sempre più è destinato a vivere di commistioni e di influenze reciproche.
Se questa trama di indizi parla chiaramente della nuova configurazione dello spazio tra media, una configurazione che vede la serie tv procedere sempre più spesso dal franchise di successo o promanare dall’Universo Cinematografico di turno, l’inquadramento del fenomeno è, però, politico.
Che bisogno avrebbero le serie tv, dopo tutto, in un passaggio di ruoli e di figure professionali dall’una all’altra parte del modello narrativo, di transitare sul grande schermo quando, in un certo senso, lo hanno già conquistato? Dalla seconda metà degli anni 2000, da quando cioè il modello seriale ha sviluppato un suo canone e un suo formato specifico, emancipandosi dalle strutture ingessate dei generi, si è parlato di una contaminazione tra narrazione cinematografica e serialità, dove era quest’ultima a beneficiarne. Adesso, con quella che è stata definita l’età dell’oro delle serie tv, la rotta si è però invertita.
Un esempio su tutti è il cliffhanger, il gancio che chiude una puntata tenendo desta l’attenzione dei fan. Sempre più diffuso nei franchise (un appellativo che viene dal marketing e non dal sistema della creatività), il cliffhanger è diventato la cifra di un sistema produttivo oligopolistico, quale è oggi Hollywood, che deve fidelizzare il pubblico, per tenere stretta a sè un’audience sempre più sfuggente e più smaliziata. In una fase calante del cinema blockbuster, che si reinventa in queste forme narrative, rendendole quasi sclerotizzate, la domanda suona ancora più forte: che bisogno hanno le serie di arrivare al cinema e, in modo particolare, ai Festival?
Rovesciando la questione, non sono forse i Festival, al contrario, ad avere bisogno dei prodotti televisivi in una fase calante della loro importanza? Per quale ragione, se la comunicazione cinematografica sempre più spesso rinuncia al critico come intermediario autorevole, sfruttando altri canali di marketing per arrivare direttamente al pubblico?
L’irruzione, da qualche tempo a questa parte (a Venezia, ad esempio, quest’anno è stata premiata Frances McDormand, che per l’occasione ha presentato la mini-serie HBO Olive Kitteridge), del fenomeno televisivo ai Festival può essere spiegata, in questo contesto, come necessità reciproca. Da una parte del sistema cinematografico di rivitalizzarsi, guadagnando appeal, con il prodotto più maturo e più evoluto del momento, dall’altra parte, il bisogno della serialità di legittimarsi all’interno di un sistema istituzionale come quello dei Festival, da sempre sismografo delle tendenze e delle mutazioni in atto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA