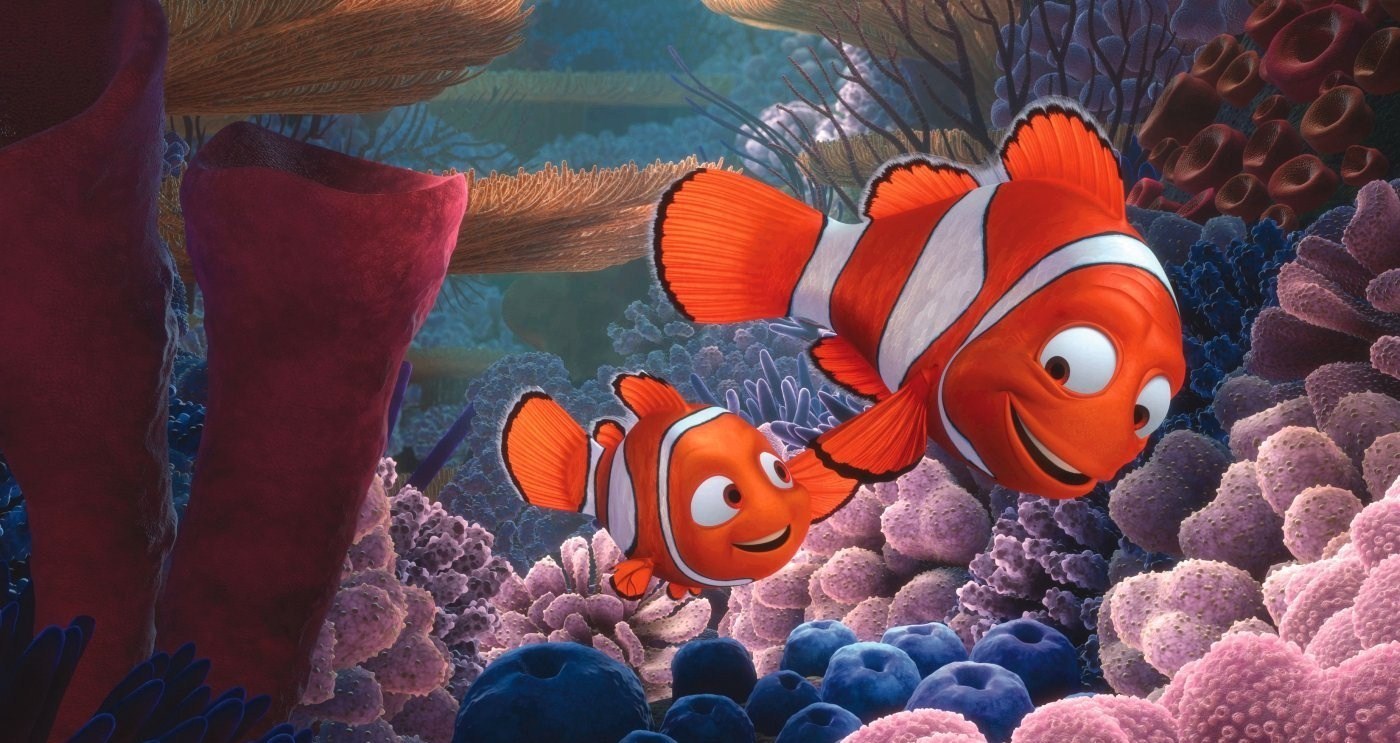La sfida con cui Matteo Garrone ha deciso di confrontarsi era senza dubbio delle più proibitive: fare i conti col Pinocchio di Carlo Collodi, probabilmente il testo dal più forte impatto popolare nel nostro paese e romanzo picaresco dai cui adattamenti in molti sono usciti con le ossa rotte, richiedeva una buona dose di coraggio e anche di incoscienza. Il regista di Gomorra, che ha iniziato a disegnare il celebre burattino fin dalla tenera età di sei anni e coltivava quest’ossessione da molto tempo, vi è arrivato però gradualmente, riuscendo nell’impresa dopo quattro anni complessivi di lavoro.
Nel frattempo ha girato anche l’acclamato Dogman e si è anche sobbarcato un fantasy dark e d’autore come Il racconto dei racconti. Il suo Pinocchio, da questo punto di vista, è invece uno slancio più nelle sue corde, dal respiro meno forzatamente europeo e più italiano: il racconto di Collodi, uscito a puntate dal 1881 al 1883, affresca infatti una galleria di archetipi cristallizzati da tempo immemore nel nostro immaginario collettivo, ai quali non è però affatto semplice dare nuova vita in maniera stimolante e originale.
Non stupisce, dunque, che il cineasta si sia mosso in un’ottica di fedeltà rispetto alla fiaba di partenza, nel tentativo di riappropriarsi del suo spirito primigenio e di farlo contemporaneamente riscoprire al pubblico generalista delle feste natalizie. L’operazione, in tal senso, è pienamente riuscita: il Pinocchio di Garrone è una sontuosa illustrazione di quel classico senza tempo, graziato da un occhio sopraffino che ha mosso i primi passi nella pittura e che in questo caso si è lasciato suggestionare tanto da Enrico Mazzanti, storico primo disegnatore di Pinocchio, quanto dai quadri dei Macchiaioli e alle tavole di Bosch.
Fonti d’ispirazione che si traducono in una confezione estremamente controllata sul piano visivo, nella quale la scenografia di Dimitri Capuani e la fotografia di Nicolaj Bruel fungono senza ombra di dubbio da valore aggiunto. Alla base di tutto, nondimeno, c’è il motore primario del cinema dell’autore romano, quella fascinazione per il lato favolistico e dolciastro della mostruosità e di tutto ciò che essa comporta in termini di struggimento e sospensione. Qualcosa che contraddistingue la sua poetica nel profondo e che trova in Pinocchio uno sfogo naturale, da molti punti di vista perfino obbligato nel far convivere organico e inorganico, legnosità e umanità, deformità e innocenza, paternità devota e figliolanza inarginabile.
Non a caso il Pinocchio di Garrone presenta una componente oscura che, pur nella magia edificante ed educativa del Pinocchio tradizionale, fa capolino in modo scomposto e pressante, a tal punto da lambire il rischio di apparire a tratti freddo e di maniera. Molti personaggi, anche grazie al trucco prostetico del due volte premio Oscar Mark Coulier per la saga di Harry Potter, sono rappresentati in chiave deliberamente ferina e animalesca, da quelli più di passaggio (il giudice scimmiesco di Teco Celio, protagonista di una singola scena prossima alla gag da umorismo nordico e surreale) ai più noti e imprescindibili, come il Grillo Parlante di Davide Marotta e soprattutto il Gatto e la Volpe interpretati da Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, voraci e viscidi come non mai, imprigionati in un loop autistico e addirittura inquietante in cui il primo è tutti gli effetti l’eco riverberato del secondo.
Ed è proprio Ceccherini, con una scelta spiazzante e un po’ sorprendente, ad avere affiancato Garrone in sede di sceneggiatura man mano che il copione prendeva corpo: il contributo del comico toscano, una maschera straordinariamente aliena al bon ton e in quanto tale rimossa dal nostro panorama mainstream, si riflette in un andamento a tratti gradevolmente sghembo e obliquo. Se la sua Volpe è forse in assoluto il personaggio più respingente, per come cattura la sensibilità borderline del suo interprete, la sensazione è che tutto il film sia incline a coccolare il piacere di smarrirsi nel flusso degli eventi collodiani, con ampie spruzzate di ironia e un bisogno evidente di tenere insieme il tocco garroniano e uno scheletro narrativo talmente noto e spremuto da risultare immutabile.
A rubare la scena, fin dalle prime battute, è però il Geppetto di Roberto Benigni: far interpretare a lui il ruolo del falegname che costruisce un burattino di legno in grado di parlare e muoversi da solo, incarnato dal piccolo Federico Ielapi, non è solo un risarcimento generosissimo per il suo fallimentare Pinocchio del 2002, ma anche una decisione che si rivela molto azzeccata. Benigni non era infatti così in parte da anni e il suo Geppetto è animato da un candore sdrucito e neorealista che regala al lungometraggio di Garrone le incursioni di maggiore commozione e tenuta emotiva. Oltre ad amplificarne il sentore di manualità, di povertà tangibile e stropicciata, che si può toccare con mano dall’inizio alla fine al di là di tutte le rifiniture patinate, intercettando così il mondo contadino di fine Ottocento (si muovono in questa direzione anche i costumi di Massimo Cantini Parrini).
Più vicini a Il racconto dei racconti sono invece i momenti dedicati alla Fata Turchina portata sul grande schermo dall’attrice francese Marine Vacth, una presenza più che mai delicata e impalpabile ma irrimediabilmente gotica e burtoniana, fiancheggiata dalla Lumaca (Maria Pia Timo) e da una versione più giovane di se stessa che introduce nel film l’elemento della doppiezza tra giovinezza e maturità, tra sregolatezza dell’infanzia e necessità di scendere a patti con i propri desideri più indicibili ma anche più pericolosi e controproducenti sul piano sociale (l’essenza di Pinocchio, in fondo, tra i mille risvolti metaforici sui quali ci si potrebbe soffermare). Ed è impossibile non citare, infine, l’apparizione nei panni di Mangiafoco di Gigi Proietti, che in pochissimi minuti riesce a dare al suo personaggio un tepore e una statura da pelle d’oca, a metà strada tra i grugniti e le lacrime.
© RIPRODUZIONE RISERVATA