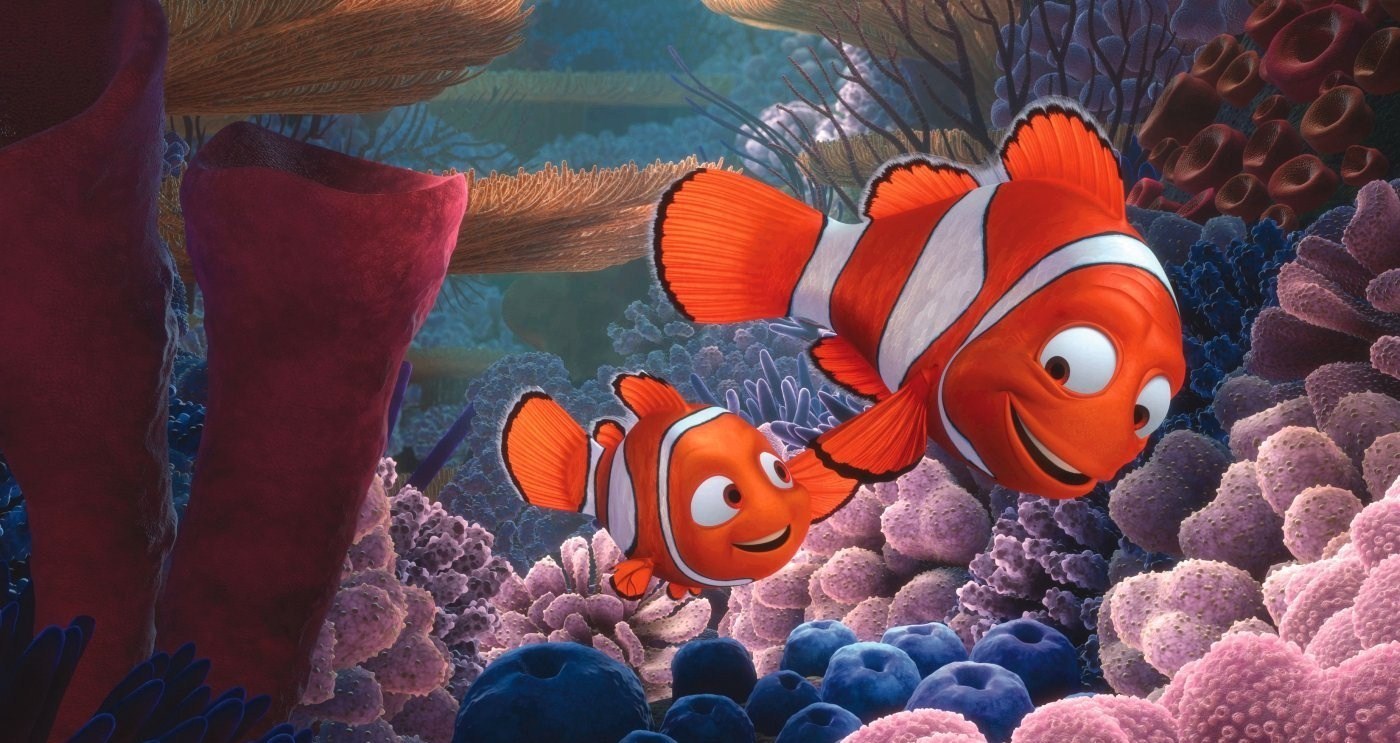James Bond (Daniel Craig) si gode un’esistenza tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato a vita privata con l’amata Madeleine Swann (Léa Seydoux). Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter (Jeffrey Wright), un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto.
Incombe infatti una minaccia internazionale e la missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain, il terrorista Lyutsifer Safin (Rami Malek), armato di una nuova e pericolosa tecnologia, con sullo sfondo il conflitto tra CIA e MI6.
Venticinquesimo film della saga di 007, a lungo rimandato a causa della pandemia, No Time to Die si è rivelato non solo il film che chiude l’era di Daniel Craig nei panni dell’agente segreto britannico per eccellenza ma anche un compendio crepuscolare del personaggio. Un uomo che prima d’ora non ci era mai stato presentato in vesti così fragili e contemporanee e che, nonostante tutto, conserva persino qualche monile nostalgico del passato, come l’Aston Martin DB5 di Sean Connery e poi la DBS anni ’70 di George Lazenby in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà, il capitolo con cui No Time to Die condivide peraltro dei rivoluzionari ed epocali risvolti familiari.
«Fool me once, fool me twice / Are you death or paradise? / Now you’ll never see me cry / There’s just no time to die», scandisce con languore malinconico la title track di Billie Eilish, tappeto sonoro fondamentale di un’operazione che provvede inesorabilmente, lungo tutte le oltre due ore e quaranta di durata, a smontare ed erodere quasi tutti gli aspetti più granitici del mito di Bond, rifondendo da zero l’immaginario di un’icona pop che abbiamo sempre creduto di conoscere a memoria, ritrovandola puntualmente uguale a se stessa di film in film.
La sceneggiatura firmata da Neal Purvis, Robert Wade e dalla Phoebe Waller-Bridge di Fleabag, autori dello script insieme al regista Cary Fukunaga, hanno ridotto al lumicino lo sfoggio di gadget sgargianti e futuristi, ma anche di smoking, Martini, avventure esotiche e condiscendenza femminile verso un seduttore che non deve chiedere mai, aprendo la breccia di un romanticismo apocalittico che è disseminato quasi in ogni sequenza e dialogo di No Time to Die, con dei ripiegamenti intimisti che Danny Boyle, sottratosi al progetto per divergenze creative, difficilmente avrebbe voluto o saputo gestire.
A dispetto del titolo, che si muove in una sorta di paradossale zona d’ombra, No Time to Die è per l’appunto un film sul congedo e sullo scolorimento irreversibile di un oggetto di culto dell’intrattenimento pop, che tornerà comunque in modi e forme che non ancora non ci è dato sapere e che qui sembra abitare la scena e l’azione con un senso di lutto e una verosimiglianza assolutamente inediti. Anche le missioni più ardite non sono uno svolazzo passeggero, e perfino le più avventate ospitano al loro interno delle campane a morte.
No Time to Die potrebbe sembrare, alla luce di queste premesse, un film fin troppo gravoso, è invece anche accorto e intelligente nel gestire la presa di coscienza e l’elaborazione di un lascito sconfinato. Ha al suo interno un peso specifico e una raffinatezza nella messa a punto delle scene d’azione, molte delle quali coreografate davvero a meraviglia (si veda la battaglia nella giungla), da risultare non solo il miglior film della lunga fase Craig, proprio in chiusura, ma anche un frammento conclusivo in grado di rileggere retrospettivamente le coordinate di una franchise che ultimamente aveva spesso accusato ripetitività e stanchezza. Ed è contemporaneamente capace di rifondarli, questi parametri, con un brivido di vitalità che alberga negli occhi di Bond – letteralmente – e che non diventa mai sterile nemmeno al cospetto dei passaggi di sceneggiatura più lacrimevoli e a tratti stucchevoli.
I titoli di testa di Daniel Kleinman, un coacervo di amore, eliche di DNA, ingranaggi vitali e omaggi citazionisti per cultori bondiani, in particolare a Agente 007 – Licenza di uccidere (1962), sono la sintesi perfetta di un approccio che non teme di lavorare su singole trovate traghettandole su un piano simbolico più ampio, come nella sequenza in cui Craig sparisce dal campo visivo di Madeleine e i finestrini del vagone di un treno diventano, idealmente, i fotogrammi di una pellicola che continuano a scorrere prima che si concretizzi la sua assenza.
Anche Craig, dal canto suo, recita in modo molto diverso dal solito: non si limita al folgorante impatto fisico della sua presenza scenica, sempre immane ed esplosivo, ma coccola partiture sentimentali mai così sottolineate in un Bond movie. Ogni dialogo con i suoi nemici, dal Blofeld di Christoph Waltz al nuovo villain di Malek, si configura come una sorta di shakespeariano rendez-vous da recitare con un’avvolgente e corposa dose di ironia e dialettica in pieno stile british. Ogni personaggio trae luce da quest’approccio dalla scrittura, guadagnando in consistenza e spessore rispetto ai passati film della saga, e non fa eccezione nemmeno l’agente segreto doppio zero Nomi (Lashana Lynch), indicata da molti come una possibile erede di Craig, giunto qui all’apice ideale – anche sul piano strettamente personale – dei cinque lungometraggi su Bond che ha interpretato.
Rispetto ai film di Sam Mendes, dall’eccezionale Skyfall allo sbiadito Spectre, lo slancio di Fukunaga, primo americano dietro la macchina da presa per un film di Bond, è poi nel bene e nel male meno cattedratico, con meno orpelli e una maggiore umiltà che ben si raccorda a questo lungo, lunghissimo addio vissuto con una sorta di religioso, ma non per questo non affettuoso, distacco. Lo si vede anche nelle scene più tradizionalmente bondiane, dal secondo blocco del prologo ambientato a Matera fino al momento più da “vecchio film di Bond” della parte cubana con protagonista una sensuale, ironica e magnetica Ana de Armas nei panni di Paloma.
I languori umanissimi di No Time to Die, a pensarci bene, stanno già tutti in una scena in automobile vissuta da Bond all’inizio in compagnia della sua Madeleine, girata come fosse un film della Hollywood classica. «Vai più veloce», dice lei guardandolo con occhi dolcissimi e innamorati e accarezzandogli i capelli mentre guida, ma James risponde: «Non c’è bisogno di andare veloci. Abbiamo tutto il tempo del mondo». Di tempo davanti a sé ne avrà anche il personaggio, visto che alla fine dei titoli di coda torna, nonostante tutto, il classico mantra James Bond will return. Ma sarà, scommettiamo, tutta un’altra storia, e tutto un altro Bond.
© RIPRODUZIONE RISERVATA