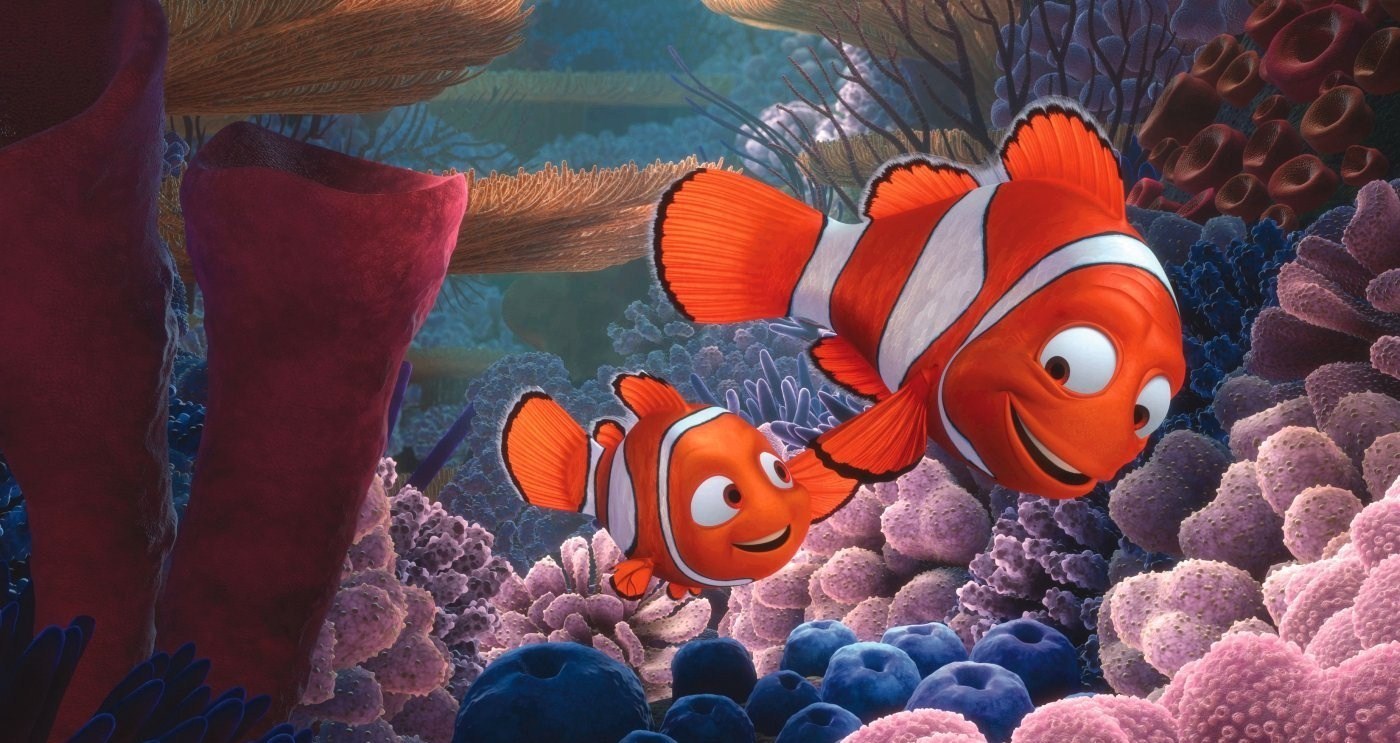Non sono bravo a lasciare. Quando ho amato e ci ho tenuto davvero, non sono mai riuscito a scrivere la parola fine. E non perché ab-bia mai avuto paura di essere abbandonato. Mi spaventa di più abbandonare. Ci sono delle ex con cui è stato un disastro dall’inizio e con anni di relazione di cui a malapena ricordo il nome e persone entrate e uscite per poche ore nel- la mia vita che ancora vorrei chiamare. Sono stato lettore feroce e appassionato delle storie di Rat-Man, di Leo Ortolani. Gli devo moltissimo, in tutti i sensi. Ebbene, il venerabile ha ben deciso di chiudere la pubblicazione del suo fu- metto. Aveva detto che si sarebbe fermato al numero 100, è arrivato a 122. Ma non per me. Vedete, la lunga epopea di questo supereroe si dipana per 112 numeri e poi finisce in una lunghissima storia che dura dieci numeri, gli ultimi dieci numeri, in cui tutto finisce. Io ho quei dieci numeri. Ho le ristampe quadrimestrali, di quei numeri. Ho le ristampe nel formato gigante. E ho il volume conclusivo, che le contiene tutte. E non le ho mai lette. Se non le leggo, non è mai finito davvero. Sono fatto così. Che è assurdo, perché io non guardo le serie proprio perché, per me, le cose devono iniziare e finire. Sono, quindi, geneticamente impostato per il binge watching, ma lo detesto. E soprattutto, preferisco sempre guardare dieci film che dieci puntate o episodi di qualunque cosa. Ho capito che, considerando il periodo che stiamo vivendo, tutto quello che ho sempre rimandato (vedere, guardare, scrivere) dovrò farlo ora, o sarà costretto a tacere per sempre. Non ci sarà un’altra occasione. Mi sono buttato su tutto quello che avevo sempre detto che avrei guardato, comprese tutte le cose che per anni ho millantato di conoscere bene. Come la maggior parte dei film francesi di qualche anno fa. Ho recuperato, per bene, Kieslowski. Sempre intervallandolo con un film di Bud Spencer, per continuare a fagocitare e non essere fagocitato. Ho riempito tutti i buchi e mi sono infilato in anfratti nuovi. In questo, lo ammetto, le piattaforme in streaming e Sky sono sta- te fondamentali. Poi, un giorno piovo- so di marzo, il tentacolare ammaliatore dalle orecchie grandi mi sbatte il suo “Plus” sul mio nasone. E lì, per due settimane, finisce la mia vita, recuperando ogni singola serie della mia infanzia, dai Gargoyles alla prima versione di Duck Tales (perché, ne esiste un’altra? Naaaa), passando per una bella rinfrescata maratonesca di tutto il Marvel Cinematic Universe e accettando la sfida di guardarmi, finalmente e nel giusto ordine, tutti i Guerre stellari (Sì, li chiamo così, venitemi a prendere a casa!) Ogni volta che provavo a iniziare una serie, c’era sempre un film che mi costringeva a cambiare idea. E ne valeva sempre la pena. Anche perché, di serie, ne ho viste tante. Davvero. E quasi tutte bellissime. Ma ce n’è una che per me è in assoluto la più bella di tutte. Quella che mi ha costretto ad urlare al capolavoro in troppi episodi. Che mi ha stretto le budella come e peggio di come faccio io quando butto sulla brace i fegatini di cavallo. Che mi ha costretto a rivederne lunghe parti per cercare di capire come avessero potuto scrivere una sceneggiatura così perfetta, dove fosse nascosto il segreto. Senza mai trovar- lo. Che mi ha fatto crescere con i protagonisti, invecchiare con loro e cambia- re senza che nemmeno me ne rendessi conto, come nemmeno Goku che passa da bambino a nonno in 400 episodi e tre serie ha saputo fare. Che mi ha reso una persona migliore, ecco. E lo dico senza iperboli di nessun tipo. Ed era rima- sta a metà. Dell’ultima stagione. Con un cliffangher di quelli veri, non quei finti tagli sentimentali alla Casa di carta. Quell’ultima stagione, al crepuscolo di un 2019 orrendo, seppur lasciata a metà, mi aveva colpito come se fossi Creed e lei Drago. Il primo Creed, ovviamente E non parlo certo del profumo di Michelle Obama. Era fine ottobre, pioveva come nemmeno in Blade Runner (a proposito, ho visto il 2049 e voglio bene a Ryan Gosling ma quel film non esiste finche non arriva Harrison Ford) e io mi chiedevo come potesse un personaggio con la testa di un cavallo, disarmarmi così tanto. Era stata una stagione bellissima. Una serie bellissima. E non volevo affatto sapere come finisse. A fine gennaio, Netflix pubblica la seconda e definitiva parte della sesta e finale stagione di Bojack Horseman. Se non la guardo, non finisce, mi dico. E tengo duro per un mese e mezzo. Poi, semplicemente, Covid. E capisco che devo affrontare la cosa. Un episodio al giorno, mi dico. Come con This Is Us. Uno solo. La finisco tutta insieme. E da allora, ogni giorno, tutti i giorni, almeno una volta al giorno, riguardo l’ultimo episodio. E si ferma tutto. La quarantena, la paura, l’insicurezza, il respiro. E non ho mai visto una cosa così bella. Così emozionante. Così perfetta. Così tremendamente potente che dopo anni, mi ha rimesso voglia di fare questo lavoro. Mi ha ridato stimoli. Uno in particolare. Di riuscire, un giorno, a procurare la stessa emozione con qualcosa di mio, a qualcuno che la stia guardando. La stessa che avevo da ragazzino. Nel frattempo, ogni giorno, tra un vecchio film e uno nuovo, un articolo di Luca Bottura e l’ennesimo impasto fatto a mano, un episodio di This Is Us (non più di uno al giorno, i miei dotti lacrimali non lo sopporterebbero) e una manciata di primi episodi di quelle serie che “devi guardare per forza” subito dimenticati; ogni tanto mi fermo, guardo fuori dalla finestra e, giuro, a voce alta esclamo: “È stato bello, finché è durato”.
Brano ascoltato in loop mentre scrivevo: Mr Blue – Catherine Feeny
© RIPRODUZIONE RISERVATA