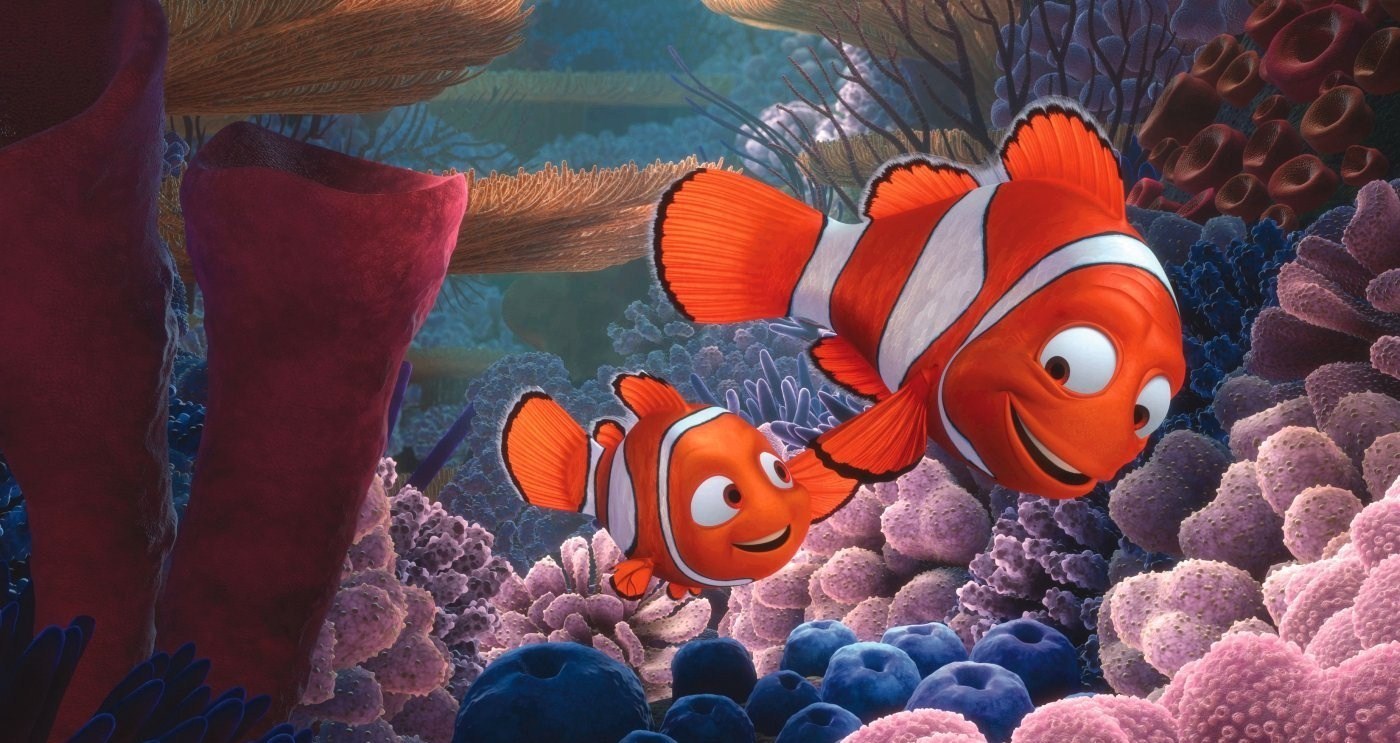Italiani brava gente recitava il titolo di un film del 1965 sulla Seconda guerra mondiale. Non è difficile immaginare come e perché in poco più di cinquant’anni siamo diventati gente molto brutta, se si accetta (ed è difficile non farlo) la fotografia sociale gelida e spietata realizzata da Paolo Virzì in Il capitale umano (film in uscita domani), thriller dal cuore profondamente nero che inaugura alla grande il 2014 per il cinema italiano. Nel segno della qualità: per il sapore universal-internazionale della storia, per l’elevato livello della recitazione dei protagonisti (Bentivoglio, Gifuni, Bruni Tedeschi, Golino, Lo Cascio e un’esordiente di grande talento di cui diremo meglio dopo), per la complessità dell’intreccio a puzzle che si rivela pezzo dopo pezzo, per l’importanza dei temi toccati…
È un apologo durissimo quello messo in piedi dal regista toscano, che in questo frangente abbandona totalmente il sarcasmo leggiadro delle sue storie toscane (Ovosodo) o il cinismo ruspante di quelle romane (Tutta la vita davanti), per trasportarci in un Nord grigio e spettrale, in un paese della Brianza con desinenza in –ate (l’immaginaria Ornate), in cui l’ordine esterno e l’opulenza delle sue villone milionarie si contrappone al disordine interiore dei personaggi, tutti bramosi di una vita migliore, più agiata, in qualche modo felice.
Il film è suddiviso in tre capitoli, con anche un’apertura e una conclusione. Nella prima scena il cameriere di un catering, dopo aver sparecchiato, torna a casa in bicicletta e viene travolto da un Suv su una strada provinciale. Quindi il nastro viene riavvolto per raccontare una vicenda che si snoda lungo un arco temporale di circa sei mesi tramite tre “soggettive”: “Dino”, “Carla” e “Serena”, tutte accomunate dall’incidente al ciclista, vera chiave di volta della storia. Virzì tratteggia con lo sguardo alieno di un livornese sbarcato in Brianza – e pertanto chirurgico e distaccato – un ritratto di borghesi (ricchissimi o parvenu affamati) schiacciati da meccanismi a cui non possono/riescono a opporre resistenza, persi nell’illusione di riuscire così a realizzare i propri desideri. Uno spaccato in cui i padri (le madri e le donne in generale sono figure positive), impegnati come sono a manipolare e raggirare, ne escono fuori malissimo, specie nel loro proiettare le proprie ambizioni e i bisogni di rivalsa sui figli.
Dino Ossola – il personaggio interpretato da un Bentivoglio che ha il grande coraggio di farsi viscido viscido –, è un “cretino” contemporaneo con pochissimo savoir faire e tanta fissa per il denaro, razza italica decadente in grande ascesa. Carla Bernaschi (una Bruni Tedeschi sempre stupenda nei ruoli da svampita) è la ricca moglie del cinico milionario di turno (Gifuni), con istinti materni precari e tanta voglia di spezzare la noia delle sue giornate. Serena (l’esordiente Matilde Gioli, che per bellezza, bravura e assonanza del nome è stata accostata alla Jolie) è la giovane figlia di Dino, che ha sacrificato la propria genuinità sull’altare delle ambizioni del padre (legandosi al rampollo dei ricconi di cui sopra, ma in realtà sogna un amore puro. E alla fine, tassello dopo tassello, scopriremo anche chi ha investito il ciclista come nei migliori gialli, ma rivelare di più della trama sarebbe peccato mortale…
Nella struttura il film è un meccanismo a orologeria complesso, costruito con sapienza dal team Francesco & Francesco (Bruni e Piccolo), sceneggiatori di Virzì che hanno reso cinematografico l’omonimo romanzo di Richard Amidon (edito da Mondadori) trasmigrandolo «dalla Brianza al Connecticut», luoghi poi non così dissimili dal momento che vi si orchestrano e godono i frutti di spregiudicate speculazioni finanziarie e di investimenti cosiddetti fantasma, con sullo sfondo Milano l’una e New York l’altro. C’è pochissimo da ridere in questa “commedia umana” del regista livornese – sebbene non manchino momenti di grande ironia come la riunione pro-teatro organizzata da Carla -, che è profondamente debitrice della nostra migliore tradizione amara, perché ci restituisce l’essenza di questi tempi così cinici come negli anni ’60 facevano film quali I mostri di Dino Risi. Il capitale umano fa davvero male nella sua spoglia verità, ma nel suo bruciare come uno schiaffo in faccia vale come una scossa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA