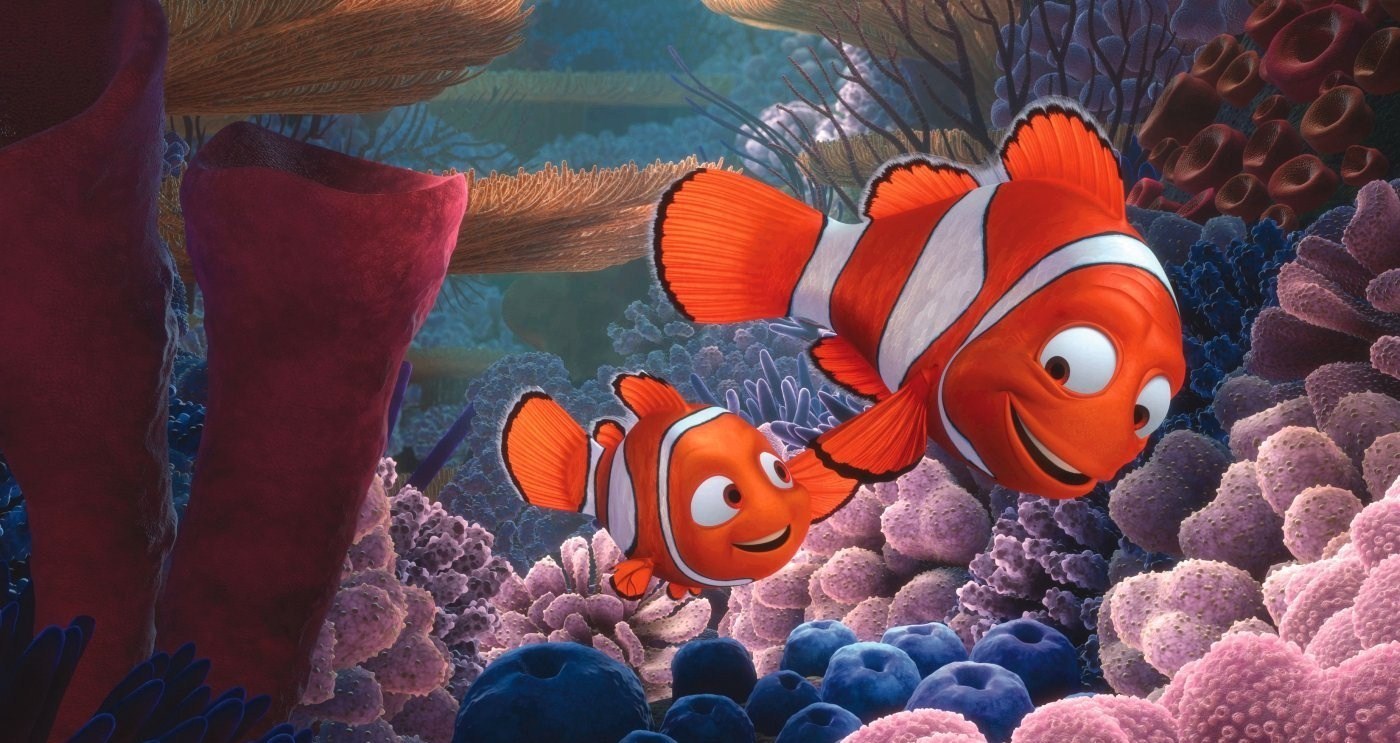The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Ben Affleck), il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia. Mentre la determinata madre del ragazzo (Lily Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate – e lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), uomo stravagante e, suo malgrado, solidale – J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali, con un piede costantemente nel bar dello zio Charlie.
Tratto dal romanzo autobiografico nonché bestseller di J.R. Moehringer, l’ottavo film da regista di George Clooney, ambientato in gran parte nella Long Island degli anni ’70 e il cui titolo italiano è, con un più sfacciato richiamo dickensiano, Il bar delle grandi speranze, aderisce con dolcezza alle atmosfere tenui e malinconiche del coming of age classico, a misura tanto di rievocazione quanto di rimpianto (il sottofondo meta-letterario del caso è offerto invece dal fatto che il protagonista, quando cresce e viene ammesso all’Università di Yale, sogna di diventare un autore di autobiografie).
L’elemento primario che più di ogni altro viene sottolineato dalla trasposizione di Clooney è l’esplorazione di una paternità surrogata, ricercata in un altrove in costante e impercettibile mutamento: se l’infanzia di J.R. è costellata anzitutto dall’ascolto della radio alla ricerca della voce del padre (lontanissimo e assente, lavora per un emittente di New York e si fa chiamare La Voce), l’età adulta è un carosello di “tipi da bar” che scorrono opachi e intermittenti, incapaci di tradurre le suggestioni in sostanza e gli ideali smozzicati in sogni pieni e corposi.
Tanto lo sguardo di Clooney quanto la sua idea di messa in scena sobria e familiare, dal canto loro, sembrano seguire pedissequamente questo medesimo tracciato (la sceneggiatura di William Monahan, purtroppo, non fa meglio), replicando i limiti delle tante caratterizzazioni inconsistenti che abitano la storia, incapaci di tradurre la propria flebile patina calligrafica in un affresco più personale e sentito (senz’altro confortevole, ma anche eccessivamente ripiegato nella propria comfort zone).
Al netto del cuore, e del tepore affettuoso del bar che ha un nome non casuale (The Dickens, appunto), la tenerezza di fondo non basta, complici anche i personaggi femminili ben poco pervenuti, a farne un film degno di nota o ad avvicinarsi anche solo lontanamente alla nitidezza carezzevole e nient’affatto frammentaria di un Amarcord alla Radio Days di Woody Allen, modello forse insuperato per questa tipologia di narrazione tanto privata quanto universale.
Foto: Big Indie Pictures, Smokehouse Pictures
© RIPRODUZIONE RISERVATA