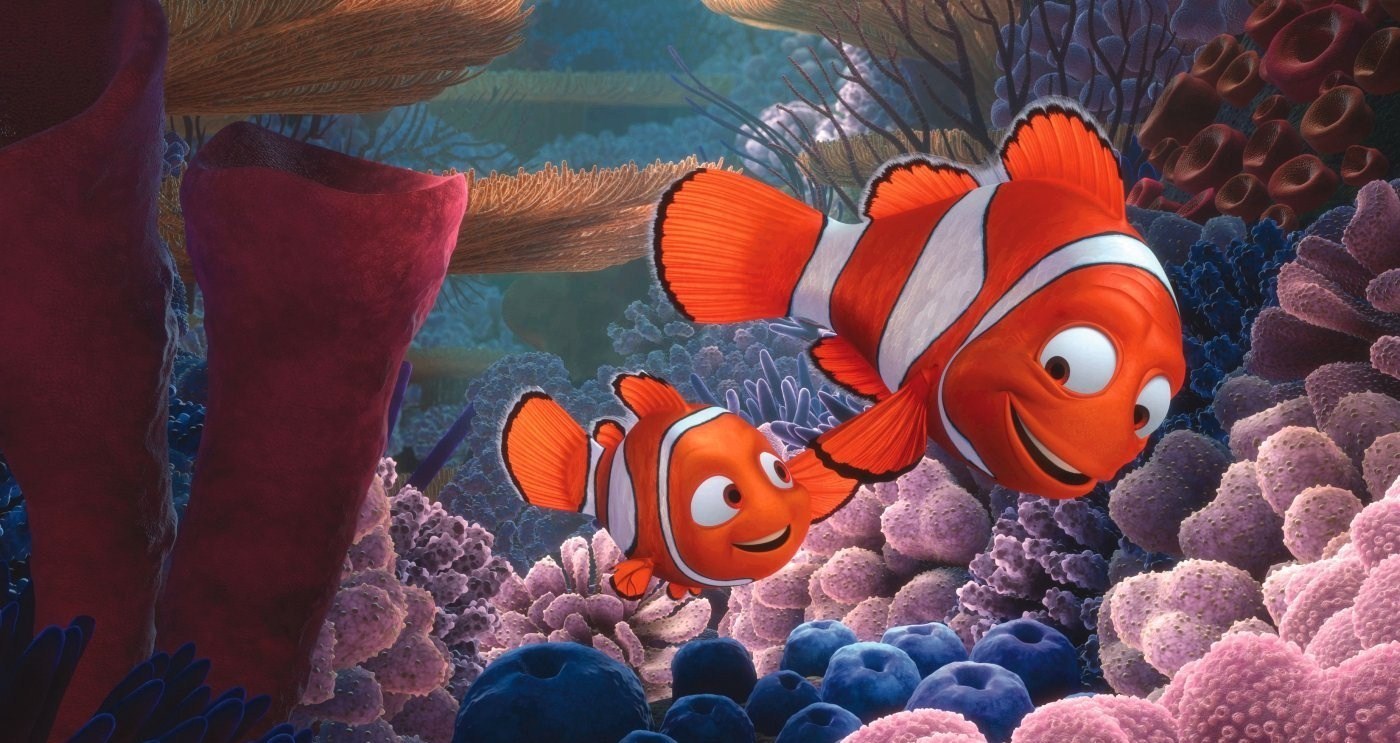Uno sfortunato talent scout, Stanley Sugarman (Adam Sandler) scova casualmente una promettente stella del basket, Bo Cruz (Juancho Hernangómez, cestista spagnolo degli Utah Jazz) vedendola all’opera in un playground di Madrid. Decide di dimostrare al mondo che entrambi hanno il potenziale per conquistare l’NBA. È la storia di Hustle, il dramma sportivo prodotto da LeBron James e affollato da grandi nomi statunitensi della palla a spicchi, disponibile su Netflix dallo scorso 8 giugno, che racconta una consueta storia di riscatto aderendo con zelo millimetrico a tutti i codici tipici di questo tipo di narrazioni cinematografiche, risapute ma spesso rassicuranti confortevoli, e trovando in Sandler un baricentro ideale e, probabilmente, il playmaker perfetto.
Rispetto alla media dei film con gli underdog che cercano di risalire ai piani alti del successo e di farlo dalla porta principale, Hustle è in realtà un film tutt’altro che pomposo e retorico e rientra in un certo filone autunnale di racconti di rivalsa, nei quali il protagonista, come in questo caso, gioca magari di rimessa, coltiva sogni e aspirazioni faticosamente e nell’ombra, si ritrova a galleggiare con fare un po’ sdrucito e malinconico in una zona grigia della propria vita in cui non c’è molto spazio per inserti consolatori e slanci facilmente ottimisti, e al massimo può esserci il solo, abusato mantra “mai arrendersi” a scandire allenamenti a fatiche sul parquet.
Hustle, diretto da Jeremiah Zagar e scritto da Taylor Materne e Will Fetters (A Stars is Born), restituisce tali pieghe e sfumature facendo un lavoro certosino di sottigliezze anzitutto su Sandler, che come spesso gli accade, a prescindere che si tratti di uno dei suoi titoli comici o di una parentesi più seria della propria filmografia, ritaglia il film su se stesso, se lo cuce letteralmente addosso, domina la scena con una barba perfetta per il personaggio, gli occhi appannati, lucidi e stanchi al punto giusto, la posa lievemente ingobbita, gli aforismi interrogativi taglienti e quasi cinici («Hai il talento, ma hai l’ossessione?», «Gli uomini sulla cinquantina non hanno sogni, hanno l’incubi o l’eczema», «Per il primo anno non avrai falli a tuo favore») o ostinatamente ostili a ogni sentimentalismo («Ho pianto vedendo Titanic, ma non gioco nell’NBA»).
Il suo Stanley è un ex talento del college basketball che ha dovuto mettere da parte definitivamente la carriera a causa di un incidente stradale, ma da scout di razza qual è finisce per essere nominato assistant coach dei Philadelphia 76ers dal proprietario, che però muore lasciando la franchigia in mano al figlio che non vede certo di buon occhio Stanley. Sandler, che aggiunge un altro singolare e prezioso tassello ai ritratti drammatici da lui offerti in film come Diamanti grezzi, Ubriaco d’amore, Reign Over Me e The Meyerowitz Stories, lo interpreta con trasporto sommesso, tanto che la sua recitazione sembra sempre guidata da un docile ma inequivocabile stato di ebbrezza, da una nostalgia ammaccata e sperduta, come se Stanley avesse imparato a nascondere l’essere su di giri sempre rigorosamente sotto pelle, a farne un asso nella manica da sfoderare solo nei momenti giusti, prontamente occultato – ma sempre in agguato – sotto una spessa coltre di rassegnazione e opacità.
Foto: Happy Madison Productions
© RIPRODUZIONE RISERVATA