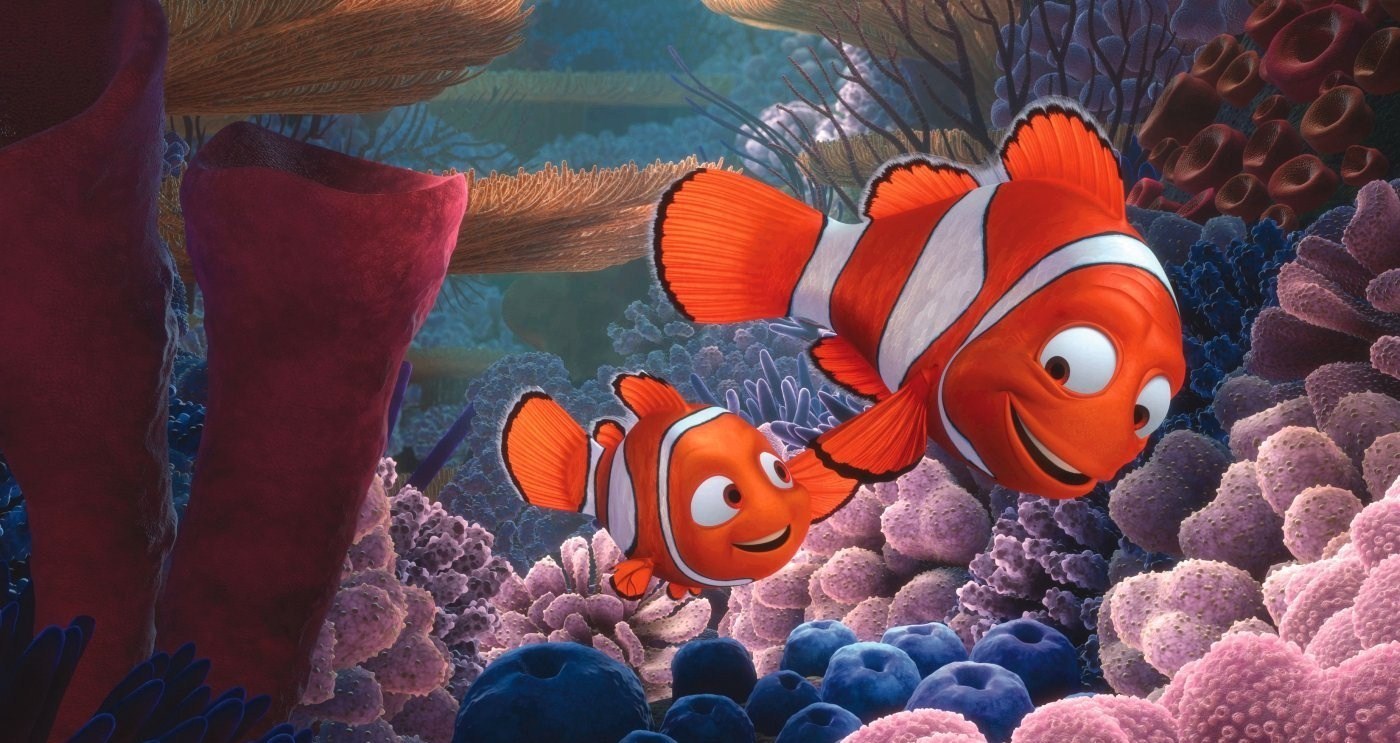Anche chi non ha più visto un cartone animato giapponese di ambientazione fantascientifica da quando era bambino, sicuramente ne ha incorporato delle sensazioni ben precise. Una persistente atmosfera malinconica e cupa di fondo, un’estetica ipertecnologica e futuristica dai tratti alienanti, scene di combattimento efficaci e un contegno emotivo dei personaggi che è figlio di un’impostazione culturale e di un’educazione molto lontane dalle nostre. Quindi, anche se non ha mai sentito neppure nominare la saga anime cult Ghost in the Shell di Mamoru Oshii, figlia dell’altrettanto cult serie manga di Masamune Shirow, non farà molta fatica a farsi catturare dal mondo e dalle atmosfere che stiamo andando a descrivere.
Diverso si fa il discorso, invece, per gli accoliti del verbo di Shirow, i cui manga si sono inseriti nel dibattito culturale degli anni ’90 per il loro sostrato filosofico che ruota attorno a una delle domande teoretiche fondamentali: ovvero, cosa sia l’anima. Questi ultimi già dalle prime ore avevano salutato l’annuncio di una trasposizione hollywoodiana dell’opera cyberpunk per mano del mestierante Rupert Sanders con preoccupazione, accusando per di più di white washing il casting ricaduto su Scarlett Johansson. Dopo aver visto il film, siamo convinti che il film possa accontentare sia gli assoluti neofiti che gli appassionati dell’anime, purché i secondi siano disposti a scendere a patti con l’inevitabile tradimento insito in questo tipo di operazioni.
Ma veniamo alla storia. New Post City (megalopoli in stile Tokyo/Shangai), in un futuro non ben precisato ma non troppo lontano. Il film (come vi avevamo già raccontato nel recap dei primi 15 minuti visti in anteprima e citando a piè pari l’anime del 1995) si apre con l’assemblaggio di un cervello umano in una struttura cibernetica potenziata ricoperta da una sorta di lattice bianco, che va a formare lo shell (il guscio) del titolo. A opera completata, sotto l’occhio vigile e materno della dottoressa Ouélet (Juliette Binoche), facciamo la conoscenza di Mira Killian (Scarlett Johansson), destinata a diventare il Maggiore della Sezione 9 che combatte i criminali hi-tech, in pratica un’arma potentissima in mano alla filogovernativa Hanka Robotics guidata dallo spietato Cutter (Peter Ferdinando). Alla ragazza viene spiegato che è stata salvata da un naufragio causato dai terroristi dove è morta tutta la sua famiglia e che solo il suo cervello (anima/ghost) è stato salvato, mentre il corpo è andato perso.
Entriamo così a gamba tesa nel tema caldo del film in odore dei replicanti di Blade Runner e che tanto ha influenzato gli allora fratelli (ora sorelle) Wachowski nella realizzazione di Matrix. Per il solo fatto di avere una minima parte del corpo “originale” si è superiori a macchine che riproducono tutte le nostre funzioni? E, viceversa, con un 95% di corpo meccanizzato, quanto è possibile ancora dirsi umani?
L’atmosfera distopica del film è resa suggestiva da un production design curatissimo nei dettagli. Tra i grattacieli della megalopoli ologrammi giganti in 3D che hanno sostituito i nostri odierni manifesti invitano le persone ad avere corpi e cervelli migliori di quelli che la natura fornisce all’essere umano, a potenziare la loro bellezza. Per intenderci, un solo collega di Mira e ancora orgogliosamente umano al 100%, mentre un altro si è fatto sostituire il fegato per poter fare la maratona alcolica dei bar senza subirne conseguenze. Una deriva non troppo lontana dal nostro orizzonte, se pensiamo al rapporto ossessivo che abbiamo sviluppato con i nostri device tecnologici.
Ma il film si spinge oltre: con i moderni cervelli che, a causa delle loro parti meccaniche, sono passibili di un’azione di hacking tanto quanto un nostro pc, con i ricordi che possono essere resettati e modificati con un semplice trasferimento dati e rendere le persone manipolabili, anche le azioni criminali si sono fatte più sofisticate. Ed è proprio di questi crimini cibernetici che si occupa la sezione 9 guidata da Mira in collaborazione col suo collega Batou (il bravissimo Pilou Asbæk) e capitanata da Aramaki (mitico Takeshi Kitano, artefice di alcune delle scene più riuscite), soprattutto da quando l’hacker più minaccioso di tutti (Michael Pitt) sta mettendo seriamente in pericolo la rete principale costruendosene una propria.
La Johansson, i puristi se ne facciano una ragione, con quegli occhi intensi e persi alla ricerca della verità su stessa e sul proprio passato, che torna a sprazzi sotto forma di allucinazioni, è perfetta per il ruolo. Come già aveva dimostrato in Under the Skin è bravissima a passare dall’inespressività robotica alla sensibilità emotiva, mentre la maestria nelle scene d’azione è figlia delle sue partecipazioni come Vedova nera nei vari Avengers.
Ed è proprio nelle sequenze action che la regia brilla di più: riprese aeree, slow motion, giochi di luce che rapiscono lo spettatore, effetti speciali esaltati da un buon 3D. Quello che più colpisce è come Sanders, noto al pubblico solo per il coloratissimo ma inerte Biancaneve e il cacciatore, abbia traghettato sul grande schermo la saga con cura e abilità, miscelando scene del primo e del secondo anime di Oshii e recuperando random vari elementi del manga, aggiungendo però piccole modifiche personali. Il live-action possiede anche un buon ritmo, pur se non adrenalinico come quello degli action a cui siamo abituati, e scene di grande impatto come quella della disturbante fuoriuscita di zampe da ragno cyber dal corpo di una geisha escort robot incaricata di distruggere i membri della Hanka Robotics.
L’unico neo di tutto il progetto, come già accennavamo all’inizio, è l’aver banalizzato la costruzione filosofica di Shirow, depauperandone il potere evocativo e preferendo una risposta più etica e conservatrice agli interrogativi che erano la colonna portante del franchise. Come evidenzia bene la frase che torna più volte nel film – «Ci aggrappiamo ai ricordi come se ci definissero. Ma è quello che facciamo a definirci» – così come la chiosa sul vero significato dell’essere umani in bocca alla Johansson nel finale. Messe da parte queste perplessità, il live action da oggi in sala è una trasposizione adulta e dai toni cupi (e che, bontà divina, non scimmiotta i cinecomic) talmente rispettosa da poter accontentare sia i proseliti sia gli spettatori dallo sguardo vergine, che speriamo siano allettati da questo primo approccio a recuperare l’opera originale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA