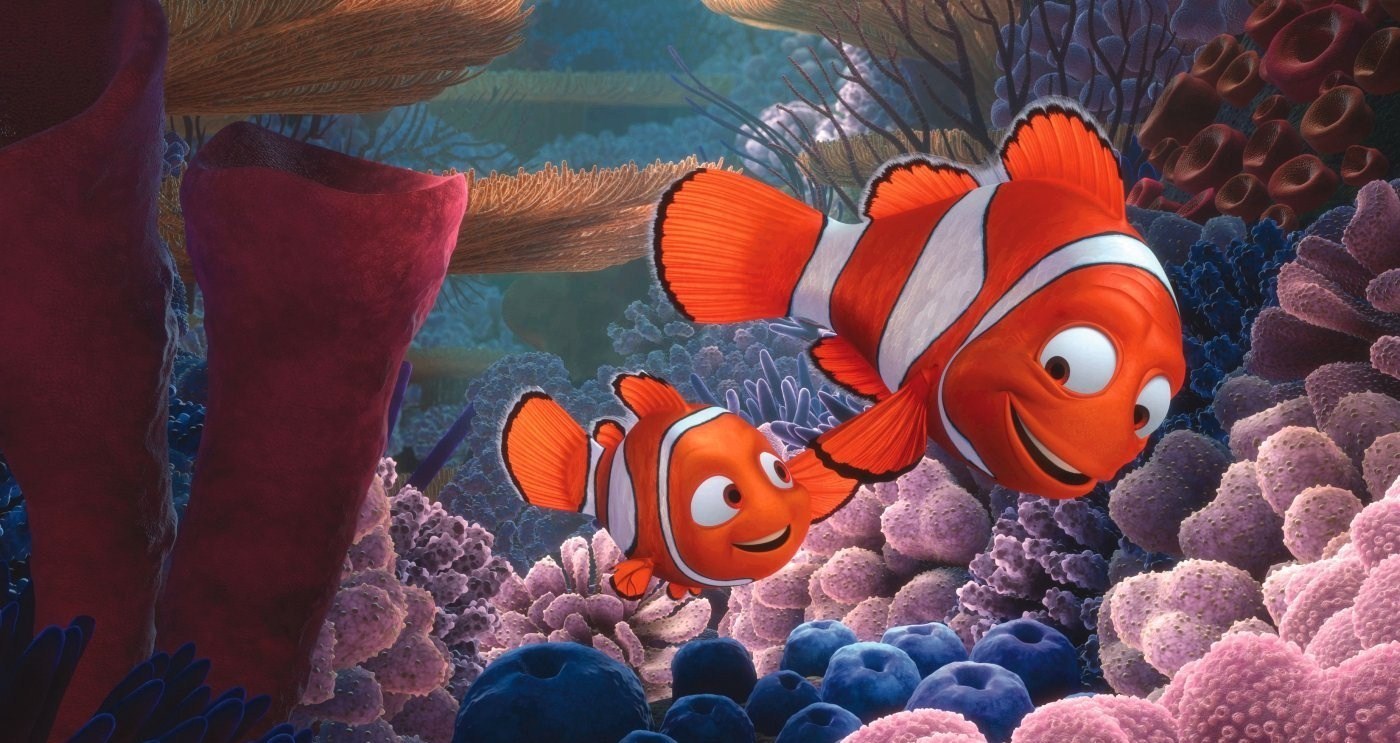Amin Nawabi, affermato accademico trentaseienne, danese di origine afghana, da oltre vent’anni tiene nascosto un doloroso segreto che rischia di rovinare la vita che si è faticosamente costruito e l’imminente matrimonio con il fidanzato di lunga data. Il regista danese Jonas Poher Rasmussen l’ha raccontato facendo ricorso allo strumento dell’animazione per tenere segreta l’identità del protagonista, suo amico d’infanzia, e farsi largo nel viaggio che ha iniziato da bambino e che l’ha portato in Europa.
Il documentario Flee, che per i prossimi premi Oscar vanta un trittico di candidature da record – miglior film internazionale, miglior film d’animazione e miglior documentario – va ad ingrossare le fila già nutrite dei film sulla crisi dell’immigrazione, aggiungendo a questo novero di titoli una voce peculiare e non stucchevole. Il racconto non consegna in eredità alcun tipo di dubbio strutturale allo spettatore, specie sull’entità e la verosimiglianza di ciò che gli viene mostrato. Lo porta nelle pieghe di una sorta di survival movie intimo e raccolto, dove l’uso dell’animazione e quello dei materiali d’archivio fluttuano e scivolano, in modo dolce e organico, l’uno sull’altro.
Amin si muove nella (sua) Storia sotto pseudonimo, con la spettralità, pur concretissima, che appartiene a certi sopravvissuti. Lo vediamo per la prima volta in 2D, mentre sussulta e sgomita per portare alla ribalta la propria vicenda, per fa emergere la propria voce di esule fuggito dal Medio Oriente da adolescente. Prima di stabilirsi in Russia e poi definitivamente in Danimarca, dove vive ora con un compagno gay, ha conosciuto dei trascorsi durissimi lontani dal Vecchio Continente, inclusa l’infanzia a Kabul ripetutamente minacciata dai talebani e dagli abusi delle autorità locali. Il padre è stato portato via dopo la presa del potere dei mujaheddin, mentre il fratello ha patito sulla propria pelle la discesa in battaglia contro le truppe statunitensi.
Flee usa come detto l’animazione, ma anche i filmati televisivi vintage e certe registrazioni video, come appiglio poetico e non certo come rifugio di comodo. L’obiettivo è sempre smussare gli angoli di certe asprezze narrative, tanto storiche e condivise quanto privatissime, come quelle appena descritte. Si tratta di un procedimento cui il cinema d’animazione cosiddetto “per adulti” nei casi migliori ricorre spesso, da Persepolis di Marjane Satrapi a Valzer con Bashir di Ari Folman, giusto per citare i casi più celebri (anche se il riferimento prettamente estetico più calzante, in Flee, è forse il rotoscope di Waking Life di Richard Linklater).
Ciò che più conta, in questi casi, è però la capacità di questo strumento espressivo – ormai non più alternativo al live action, cosa che film come Flee ribadiscono – di accompagnare con intelligenza i non detti, dissimulare i groppi in gola troppo evidenti, offrire conforto. Procurare rifugio etico e più piani di lettura delle immagini, tutti salutari. Una moltiplicazione di strumenti espressivi e formati come quella di Flee consente anche di transitare dai western ai film di Jean Claude Van Damme, tirati in ballo come passioni naïf del protagonista, all’evocazione dei dettagli più crudi. Senza frizioni e attriti troppo evidenti, con leggerezza catartica e terapeutica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA