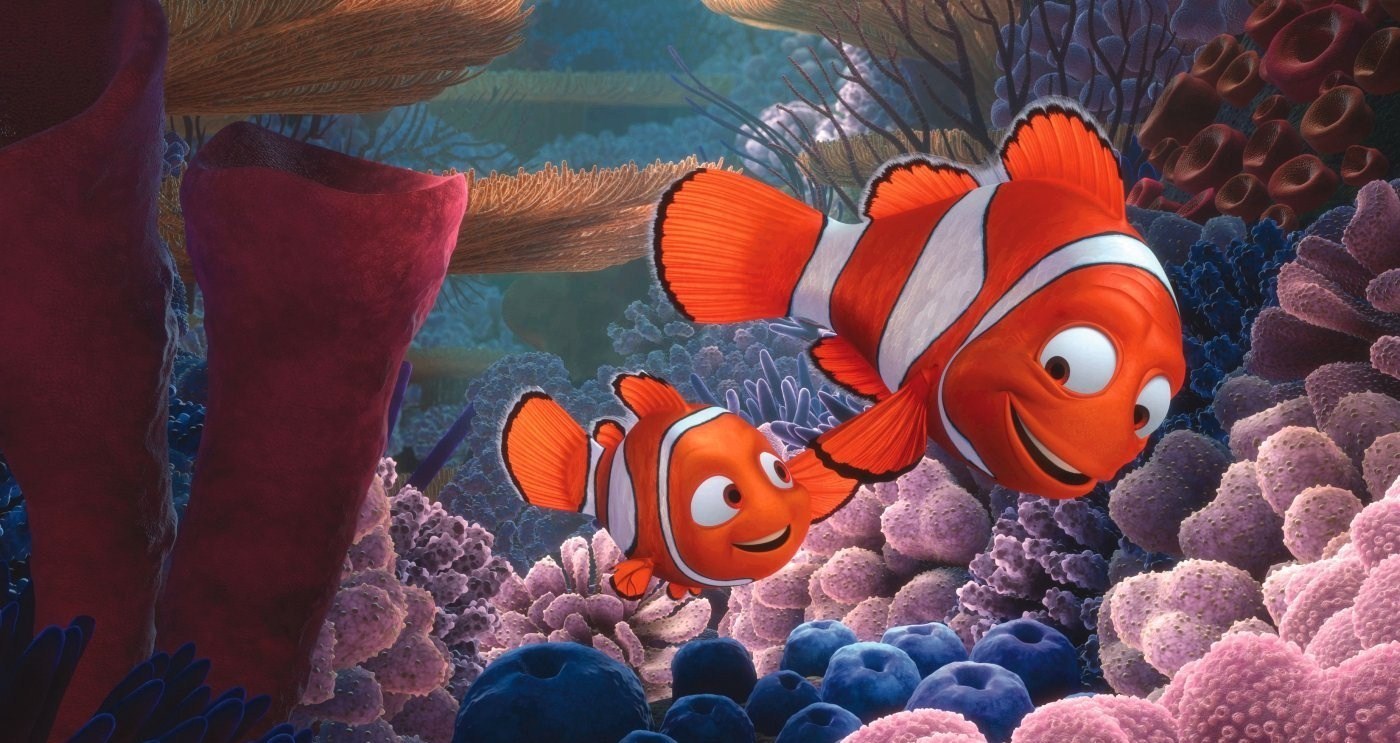Con lui i paragoni si sprecano: Volonté, Gassman, Mastroianni. Non c’è altro attore italiano come il 58enne Toni Servillo che sappia dividersi con la stessa fluidità e gli stessi risultati di popolarità tra cinema e teatro. Non c’è regista impegnato che non lo voglia come protagonista e a teatro è costretto a replicare all’infinito i suoi spettacoli per i continui sold out. Un artista a 360° a cui tutto riesce bene: canta, recita, dirige, fa lo sceneggiatore, il doppiatore… Eppure c’era qualcosa che mancava alla sua carriera: la partecipazione a una commedia. Abituati, infatti, come siamo a vederlo impegnato sullo schermo in ruoli intensi, spesso drammatici (Le conseguenze dell’amore, Il divo, La grande bellezza i più famosi), se non addirittura ieratici come quello recentemente offerto ne Le confessioni, non è immediato abbinare il suo volto a un film dai toni comici.
Mentre non è difficile immaginarselo, elegantemente seduto a un tavolino a disquisire con il regista Francesco Amato (Cosimo e Nicole) sul cinema di Billy Wilder e Woody Allen, ma soprattutto di Groucho Marx, maestro nel non prendersi mai troppo sul serio, che ha mostrato ai due la via da percorrere per mettere in piedi una storia sofisticata e brillante, quella di Lasciati andare (in uscita il 13 aprile), che si diverte a mixare il mondo delle palestre e quello della psicanalisi. «Ma ci tengo a precisarlo: il mio non è stato un contributo autoriale, ma solo di sponda» dice Servillo.
Lo abbiamo intervistato in un momento di pausa prima di una delle repliche fiorentine dello spettacolo Elvira, un testo in cui sono trascritte sette lezioni di Louis Jouvet, di teatro e di vita, a un’allieva. Ecco cosa ci ha raccontato.
Lasciati andare è la sua prima commedia. Era una sua aspirazione?
«Da tempo desideravo avere un’occasione diversa dai ruoli con cui ho raggiunto il successo, seppur con registi importanti e grazie a film piuttosto impegnati, mentre a teatro mi è capitato spesso di portare in scena opere in cui comicità e scrittura intelligente vanno di pari passo. E mi auguravo che ciò potesse capitarmi anche al cinema. Questo film già dalla lettura mi sembrava scritto con una mano felice e che fosse avvincente, anche grazie alle situazioni improbabili che propone».
In effetti, il sodalizio tra un rigido psicanalista intellettuale e una personal trainer spagnola esuberante è piuttosto improbabile…
«Ho trovato molto tenero che si aiutassero vicendevolmente a rimettersi in piedi e a prendere il coraggio necessario ad apportare dei cambiamenti importanti nelle loro vite. Sono opposti, eppure la complicità che si sviluppa tra loro è tale da suggerire che possa esserci anche dell’altro…».
Verónica Echegui, la sua partner, è una rivelazione, una presenza esplosiva. Dove l’avete scovata?
«Una bella scoperta, un’attrice piuttosto nota in Spagna che a livello internazionale ha partecipato alla serie Tv Fortitude. Troverà sicuramente la popolarità in Italia. Tra l’altro, ha imparato l’italiano appositamente per aprirsi al nostro cinema ed è sorprendente il livello che ha raggiunto, diventando credibile nei panni di una straniera che vive in Italia da diversi anni».
È vero che il regista l’ha inseguita per i teatri d’Italia per definire con lei il personaggio?
«Francesco, con grande caparbietà, mi ha accompagnato lungo la mia tournée teatrale. Abbiamo letto e riletto il copione, ragionato insieme nei camerini e nelle hall degli alberghi. Nonostante abbia solo 36 anni, è un regista molto consapevole e sente la necessità di discutere il copione con i propri interpreti».
Nel film lei è uno psicanalista. Da giovane ha frequentato la facoltà di psicologia, che poi ha lasciato per dedicarsi al mestiere di attore. Si potrebbe dire che ha preferito esplorare il mondo dell’anima con gli strumenti del teatro invece che con quelli della psicologia?
«Semplificando, sì. Senza farla troppo lunga, il palcoscenico è una forma di terapia che ti fa accedere a una più profonda conoscenza di te e degli altri, perché ci si muove nel teatro dell’interiorità, dove poter mettere in discussione se stessi ed esplorare le proprie parti più misteriose».
Quegli studi, oltre ad arricchirla, le sono serviti nel suo lavoro?
«Sono cresciuto in un’epoca di forte interesse per la psicologia, grazie a Basaglia e al movimento dell’antipsichiatria, e quindi dopo il liceo classico mi iscrissi a psicologia per approfondire questo interesse. E devo ammettere che in tutti gli anni trascorsi come capocomico, quanto appreso mi è stato davvero utile nel gestire le dinamiche di gruppi formati da almeno 25 persone».
Nel film si ironizza sull’ambiente delle palestre soprattutto in una scena molto divertente dove le vengono illustrati gli attrezzi con un profluvio di termini tecnici inglesi. Che rapporto ha con quel mondo?
«Mi sono sentito molto a mio agio in quella scena, perché non ho mai frequentato una palestra e quindi – anche se non giudico chi lo fa – non mi è stato affatto difficile assumere un’espressione perplessa».
Ha dovuto sottoporsi ad allenamenti fisici?
«No, lo abbiamo girato in sole otto settimane e, per rendere credibile la mia metamorfosi, abbiamo utilizzato una pancia finta. Io, però, a differenza del mio personaggio non sono un sedentario, anche perché il lavoro dell’attore ha nel corpo una delle sue maggiori risorse, richiede reattività e presenza. E poi sono sempre stato attivo, da ragazzo giocavo a calcio nel ruolo di terzino destro, quindi quell’impaccio e quella rigidità che mostro nel film è tutta del personaggio».
Lei è tifoso del Napoli come Sorrentino?
«Non sono un tifoso, la mia è più una simpatia».
Viene spesso paragonato a Gassman, perché è uno dei pochi attori italiani che ha raggiunto lo stesso livello di popolarità al cinema e a teatro, sebbene abbia partecipato al suo primo film a 40 anni… Come concilia questi due mondi?
«Trovo una tale ricchezza nel confondere i due ambiti e c’è un tale travaso da un’esperienza all’altra che è quasi impossibile distinguerle. Però non ho mai considerato il teatro come l’anticamera del successo cinematografico. Non ho mai avvertito una primogenitura dell’uno nei confronti dell’altro. Il paragone con Gassman mi lusinga e mi onora, perché non era semplicemente un attore, ma rifletteva sul suo mestiere e ha continuato a fare tutto contemporaneamente fino alla fine della sua vita.
Ho esordito nel cinema a 40 anni, perché all’interno della compagnia che io, Mario Martone e Antonio Neiwiller abbiamo fondato, ovvero Teatri Uniti, sentivamo il desiderio di fare cinema e da questo desiderio è nato Morte di un matematico napoletano. Anche L’uomo in più, la mia prima collaborazione con Sorrentino è nata all’interno di Teatri Uniti».
Attualmente è impegnato a teatro con Elvira di Louis Jouvet, un’opera che parla del rapporto tra i maestri e gli allievi. Quali sono stati i suoi di maestri?
«In primis proprio Jouvet, un grande uomo che ha saputo portare il cinema al massimo livello di sofisticazione, attirando però centinaia di migliaia di spettatori, così come Eduardo De Filippo che riusciva ad essere raffinatissimo e nello stesso tempo a incontrare un vasto successo popolare. Da ragazzo guardavo con ammirazione il lavoro di Fassbinder. Era adattatore, regista, faceva radio, ha messo in scena a teatro opere come La bottega del caffè di Goldoni e per la tv ha diretto la miniserie Berlin Alexanderplatz, ai tempi in cui la Rai realizzava ancora prodotti di qualità. La sua era a tutti gli effetti una factory».
Anche lei spazia molto, infatti oltre a teatro e cinema, c’è anche la passione per la musica che condivide con suo fratello Peppe. La Tv, invece, non le piace?
«Con mio fratello abbiamo appena concluso la tournée di La parola canta, un recital che celebra Napoli attraverso poesie e canzoni, ma ho anche diretto dodici opere liriche per La Fenice di Venezia, tra cui Le nozze di Figaro di Mozart e il Fidelio di Beethoven. Quanto alla televisione, non si è semplicemente creata l’occasione. Non è una questione di snobismo la mia: dovesse arrivare una proposta interessante, l’accetterei senza pregiudizi».
Lei è considerato l’attore feticcio di Sorrentino. Come si spiega che film come Il divo e La grande bellezza siano riusciti a sfondare i confini e ad approdare al successo internazionale, pur avendo un’identità italiana marcata?
«Capisco che possa sembrare incredibile, ma deriva dal fascino che proviamo verso ciò che è esotico e completamente estraneo a ciò a cui siamo abituati. La grande bellezza, nello specifico, ha il pregio di raccontare l’uomo universalmente, ma senza strizzare l’occhio a qualche modello, ma con un linguaggio proprio che però riesce a essere riconoscibile da parte di tutti aldilà della provenienza geografica. Il nostro cinema è stato grande proprio quando era in mano a registi che sapevano raccontare il nostro Paese da una prospettiva personale, come hanno fatto Fellini, Monicelli o Risi».
Aprile è il mese dei David di Donatello. C’è qualche film che l’ha colpita di recente?
«Tra i nominati ho apprezzato sia La pazza gioia che Indivisibili, entrambi molto coraggiosi nell’essere così diversi da ciò a cui siamo abituati. Vinca il migliore! Più in generale, ho amato tantissimo Il cittadino illustre di Gaston Duprat e Mariano Cohn, che combina sapientemente umorismo e intelligenza».