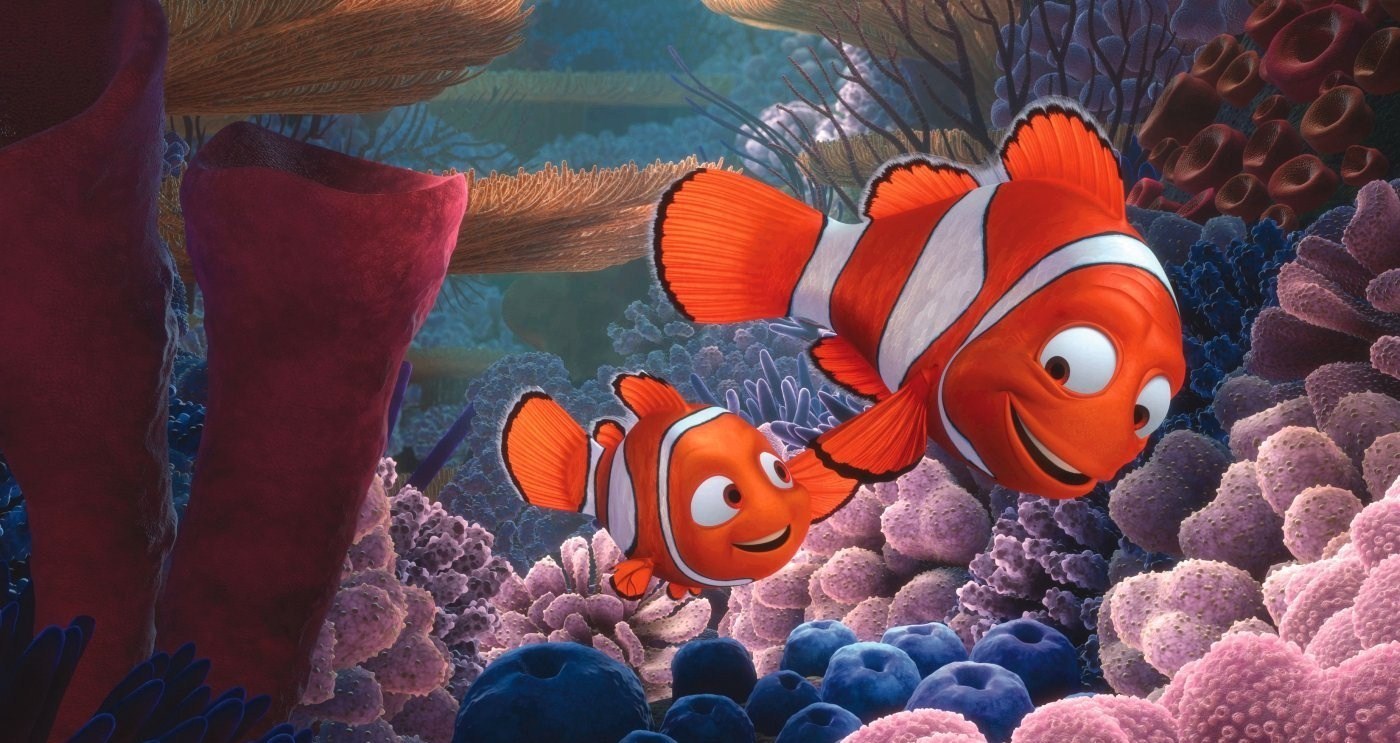Costruito montando esclusivamente materiali di repertorio e voci fuori campo, Maradona, il documentario di Asif Kapadia dedicato al fuoriclasse argentino, rappresenta per il pubblico italiano una specie di eccezione culturale. Gli anni presi in considerazione sono quelli del periodo napoletano e Kapadia sceglie come momenti cardine i due mondiali, quello vinto dall’Argentina del 1986 e quello della famosa semifinale in cui l’Italia venne eliminata ai calci di rigore: il primo apre la grande stagione dei trionfi di Diego Armando Maradona, mentre il secondo segna la fine dell’idillio con il pubblico italiano, scatenando – questa è la tesi – una caccia all’uomo mediatica e giuridica.
Indagine sociale e archeologia televisiva, quindi. Il punto è che per chi ha dai quarant’anni in su e vive in Italia si tratta in gran parte di materiali stampati nella memoria, dalle improbabili interviste di Galeazzi negli spogliatoi del San Paolo alle apparizioni nei varietà con Pippo Baudo ed Heather Parisi; dai gol più celebri (il tiro da metà campo al Verona, la punizione a due alla Juventus) agli spiccioli di cronaca giudiziaria; dal braccio di ferro con il presidente del Napoli Ferlaino (che non volle lasciarlo partire) alla paternità rinnegata di Diego Armando jr.
Il film diventa così un “Come eravamo” che acquisisce un certo spunto giornalistico solo quando affonda tra le pieghe dei rapporti tra Maradona e la Camorra benché, anche in questo caso, si tratti ormai di materiali e dichiarazioni facilmente rintracciabili in Rete. Certo, vedere Ferlaino che inveisce e caccia dalla sala stampa il giornalista che, alla conferenza di presentazione di Maradona, chiama in causa i soldi della malavita, fa venire i brividi. Così come Cristiana Sinagra intervistata dalla TV nel suo letto d’ospedale con il figlio neonato appoggiato di fianco alla testa.
Va anche detto che apparecchiare un documentario su genio e sregolatezza, avendo a disposizione la storia di Maradona, è come segnare un gol a porta vuota, quindi il film si segue con piacere e partecipazione; addirittura durante la proiezione di gala il pubblico si lascia andare a un’ovazione dopo il secondo gol all’Inghilterra nel mondiale messicano.
Il problema è che il calciatore argentino è sempre stato un personaggio iper-mediatizzato e questa raccolta di istantanee non arriva mai a svelare un secondo piano di lettura, come se il segreto del suo genio e della sua attitudine generosa – nei confronti della famiglia, dei tifosi (“la gente”, come li chiamava lui), dei compagni di squadra e perfino della stampa – fosse una questione già esaurita da decenni di esposizione al mondo.
Paradossalmente la domanda più attuale a cui il documentario risponde è squisitamente sportiva: si fa un gran parlare del più grande giocatore di tutti i tempi paragonando Messi a Maradona, misurando i successi e il carattere del secondo sui tempi tecnici del primo, diventato il numero uno in un calcio dai ritmi molto più elevati. Ecco, ripercorrere le gesta di Diego in queste due ore di “Best of” fa un certo effetto e suggerisce una risposta, perché se la velocità del football negli anni ’80 era diversa, i materiali dimostrano come il calcio dell’epoca fosse un territorio di caccia brutale, in cui rompersi una gamba o il naso – specie per uno che giocava in quel modo – era la promessa di ogni partita. Un gioco preistorico, ancora refrattario alle logiche del politicamente corretto (come d’altra parte tutta la società), violento sul piano fisico e ideologico, razzista e cattivo, che stroncava prestissimo le carriere dei suoi protagonisti.
Come eravamo, appunto, e soprattutto come era il calcio. E com’era lui, al centro di tutto, Maradona.
Foto: ©Alfredo Capozzi; Courtesy of Festival de Cannes
© RIPRODUZIONE RISERVATA