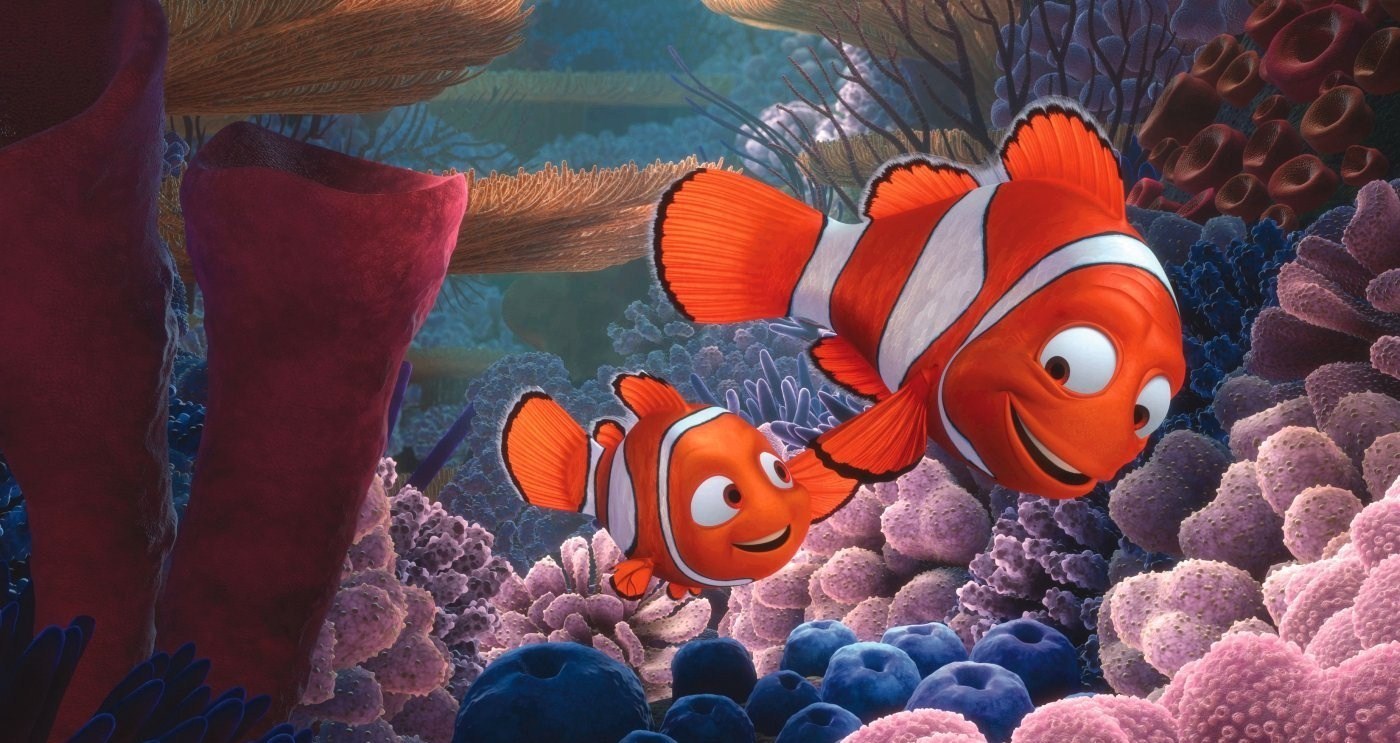«Marlon Brando era l’uomo più bello del mondo, erano tutti d’accordo su questo, uomini e donne. Non ce n’erano altri così, e credo che non ce ne saranno più». Pieno di nostalgia, Bertolucci racconta i film e le passioni della sua vita a fianco ad Antonio Monda, nel più emozionante tra gli incontri andati in scena finora alla Festa del Cinema di Roma. Ha una voce robusta, si muove tra i ricordi come un innamorato. Le memorie a volte lo portano altrove, ma c’è una lucidità coriacea nel suo girovagare, retorica da letterato e solidità contadina: alla fine torna sempre al punto.
Nella mani stringe pochi fogli scritti a penna, indice dei suoi pensieri. «Avevo proposto Ultimo tango a Parigi a Belmondo, ma lo rifiutò sdegnato. Non me lo aspettavo da lui. Delon invece voleva fare anche il produttore, e fui io a rifiutarmi. Quando infine incontrai Brando, ci trovavamo in un albergo, e mentre gli raccontavo la trama lui indicò il mio piede che batteva per terra, per mostrarmi quanto ero nervoso».
Ultimo tango a Parigi è uno dei sei film e delle sei clip che vengono mostrate durante l’evento. Ognuna libera un flusso di immagini e associazioni, un piccolo viaggio. Di Novecento, che «la Paramount tentò di affogare come un gattino», distribuendolo in poche copie nonostante Bertolucci venisse dal suo successo più grande, ricorda con rabbia ormai spenta i tagli subiti dalla versione iniziale da 5 ore. Il cut da tre ore operato dagli americani, che non venne mai proiettato e non volle mai vedere; quelli da 4 ore e 4 ore e mezza che comunque «sacrificavano scene molto belle, che davano maggiore respiro e sfumature al racconto. Quel film lo feci per mio padre, che mi ha insegnato tutto, fu un omaggio alla sua poesia».
Dell’Ultimo imperatore rivive invece una scena che lo riempì d’ansia, vista alla fine di una giornata di riprese, mentre usciva dalla Città Proibita: «Avevano convocato centinaia di ragazzi dell’esercito, e li avevano allineati su delle sedie per rasarli, poiché avrebbero dovuto fare da comparse l’indomani. Vidi questo mucchio gigantesco di capelli, mi mozzò il fiato, pensavo per associazione a momenti tragici della storia, nonostante loro probabilmente si stessero divertendo».
E poi giù giù per gli anni, fino all’ultimo Io e te, «che volevo girare in digitale, ma poi ebbi l’impressione che si ‘vedesse troppo’. Il cinema era per me come la pittura impressionista, doveva mantenere una sua sfocatezza. Così lo feci in pellicola. Ma oggi non so, credo girerei in digitale, magari il prossimo film lo farò così, c’è sempre tempo, no? Forse quella nuova definizione mostrerà qualcos’altro, qualcosa a cui non avevo pensato, l’interiorità degli attori oltre il volto…».
Si chiude sulle sue passioni, Ozu e Bresson li cita per primi, ma dice di essersi sempre sentito più vicino, come spettatore e regista, a Mizoguchi e Ophuls, a quel loro cinema pensato come un abbraccio, «un movimento che coinvolge anche lo spettatore». Proprio un film di Ophuls, Le plaisir, è l’eredità di sguardo che lascia al pubblico. «Me lo volle far vedere mia moglie, sapeva che mi sarebbe piaciuto. E mi piacque tanto che mi venne la febbre, così che dovetti vedere i tre episodi in tre giorni diversi. Continuava a tornarmi».
Foto: Getty Images
© RIPRODUZIONE RISERVATA