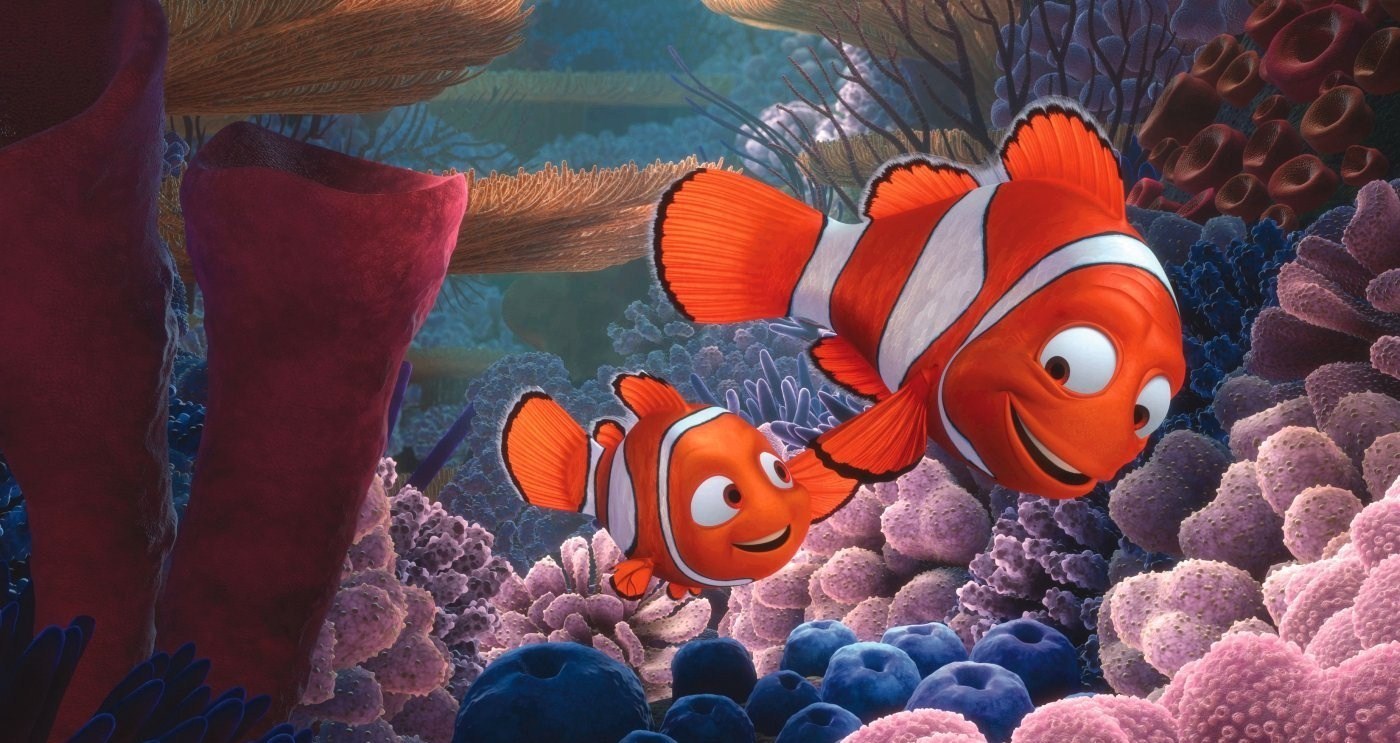Café Society di Woody Allen è film d’apertura, fuori concorso, di Cannes 69
Quando parla di sé, Woody Allen afferma di non essere una persona particolarmente curiosa: “Ho una cultura a macchia di leopardo, conosco benissimo certe cose e soltanto quelle”. Nessuno stupore che girati gli 80, anno dopo anno il suo cinema si stia calcificando dentro i mondi che conosce, stia diventando cioè una forma di malinconia per i luoghi e i periodi che ama – gli anni ’30, la costa francese o l’epoca d’oro di Hollywood, la Manhattan dei grandi club, gestita da gangster italo-americani in doppio petto.
Questo cinema, che è come un gesto – le luci ramate di Storaro, i costumi di lusso, il costante mormorio jazz, attori sempre al massimo del talento e della disposizione – lui lo esegue ormai con un mestiere che nemmeno il passaggio al digitale compromette, in un flusso di film che arrivano uno via l’altro, come una musica anche quelli, come un’idea monotona e rassicurante.
Café Society è una piccola storia d’amore tra Hollywood e New York, quella di un ragazzo, Bobby (Jesse Eisenberg, un ottimo succedaneo di Allen, che si ritaglia il ruolo di narratore), che lascia il Greenwich Village per la Mecca del cinema in cerca di fortuna, affidandosi allo zio Phil Stern (Steve Carell), potentissimo agente delle star. Lui, oltre a dargli qualche lavoretto da sceneggiatore, lo presenta alla sua segretaria Vonnie (Kristen Stewart) che gli fa girare Beverly Hills, ville d’artista e locali di incontro. L’amore potrebbe scoppiare, ma resta lì appeso, perché Phil e Vonnie hanno una relazione fuori dal matrimonio di lui. Piccolo triangolo, con tutti gli equivoci del caso, quando ognuno conosce i ruoli ma nessuno sa chi li interpreta (Phil si confida con Bobby senza mai citare Vonnie).
Poi l’intreccio si scioglie e nell’ultimo terzo di film ci si sposta a New York, a fare i conti con la famiglia del ragazzo, traccia comica del film che allaccia quella romantica.
Cinema come manovra di stile – di scrittura, di fotografia, di recitazione, di taglio e cucito – che non risolve nulla ma mette di buon umore, coinvolge con levità, è discontinuo, divertente, a tratti con vero pathos e vera bellezza (la Stewart e Blake Lively fanno girare la testa). Non sembra un’ottima scelta per chi ha pretese ipercritiche, lo è per una serata galante, o per praticare di nuovo un mondo e un autore che si ama sempre, e anche perché non ha idee al di fuori del proprio immaginario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA