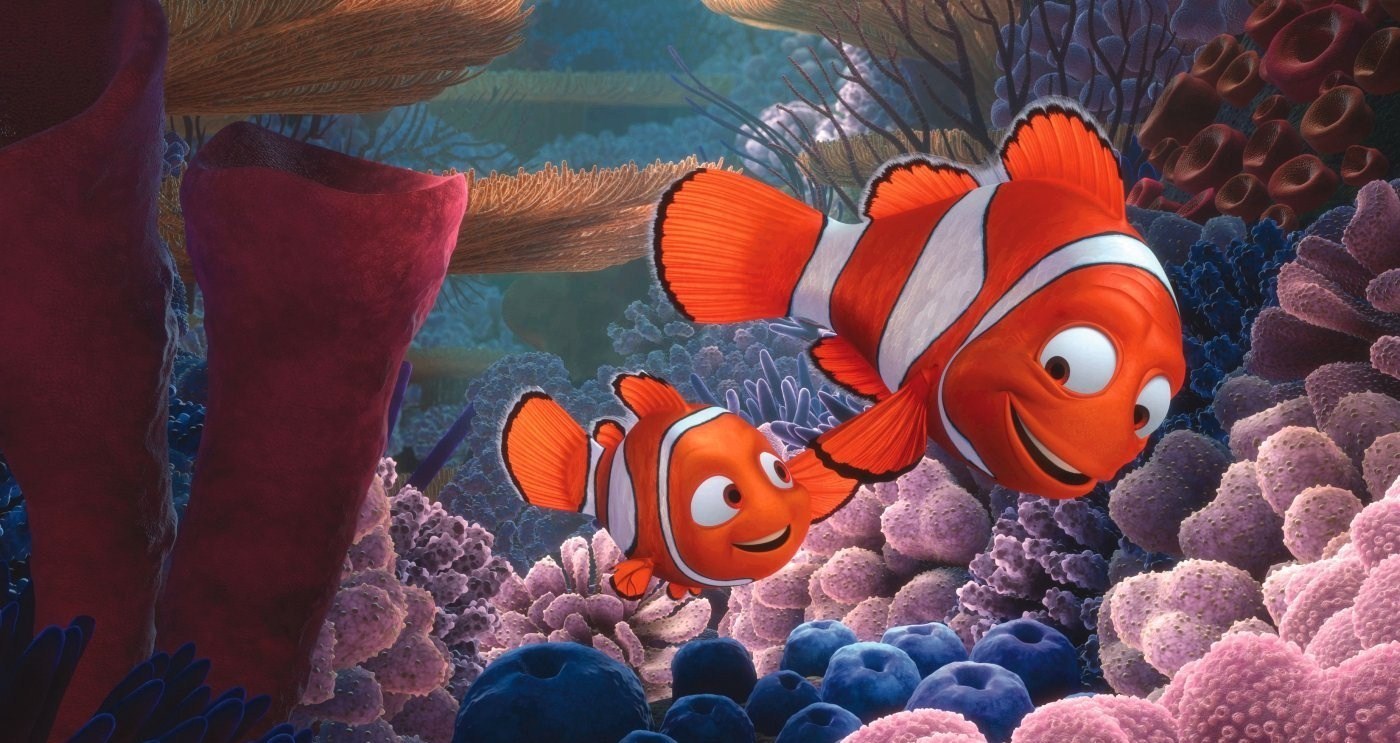The Salesman di Ashgar Farhadi è in concorso a Cannes 69
La vita normale di una coppia a Teheran, due persone perbene, oneste. Lui insegna in un liceo, sa essere affettuoso e giusto con i suoi ragazzi: e insieme alla moglie, preparano a teatro Morte di un commesso viaggiatore. Una vita tranquilla. Minata, già all’inizio del film, da un evento inquietante, eppure assorbito nella sua normalità: l’edificio nel quale vivono sta collassando, tutti devono evacuarlo. Scene da terremoto, un esodo composto di tutti gli abitanti del condominio, mentre intorno è come se il Titanic stesse affondando. Poco dopo, un evento apre il guscio della loro vita tranquilla. La moglie è a casa, sta facendo la doccia. Suonano alla porta. Con la tranquillità dell’abitudine, va ad aprire senza chiedere chi è. E torna a fare la doccia. Ma non è il marito.
Ashgar Farhadi – il regista iraniano di Una separazione, con il quale ha vinto l’Orso d’oro a Berlino e l’Oscar per il miglior film in lingua non inglese – coltiva la discrezione dello sguardo. Il pudore estremo della messa in scena. E lascia ogni azione violenta fuori dalla porta, fuori dallo sguardo. Noi non sapremo mai davvero che cosa è successo a casa della moglie, non sapremo fino a che punto si è spinta l’aggressione dello sconosciuto. Un regista diverso avrebbe afferrato l’occasione per alzare i toni. Lui no. Il marito apprende la notizia, i vicini gli danno altri particolari, la moglie è sconvolta.
Tra l’altro, piccola parentesi: tre dei film di quest’anno in concorso a Cannes hanno a che vedere con casi di aggressione sessuale. Il film di Mungiu, Baccalaureat, il film dei Dardenne La fille inconnue e il film di Farhadi. In Mungiu e in Farhadi ci sono famiglie borghesi che vedono il loro quieto vivere lacerato dall’inatteso. Ma anche qui, come in Mungiu – e in parte nei Dardenne – non ci sono pugni sbattuti, grida. Non c’è neppure una denuncia alla polizia. Il marito compone la sua personale inchiesta, con la difficoltà e la lentezza che avremmo tutti noi, nella vita. È un’inchiesta minimale, che procede per piccoli passi. E quello che conta, alla fine, non è chi sia stato. Ma, nel caso lo si scopra, come comportarsi. Che cosa è giusto, che cosa è sbagliato? Che cosa è giusto “in assoluto”, secondo le leggi divine e secondo il rigore umano. Non che cosa conviene a noi, o alla nostra famiglia. È tutto lì, il cinema di Farhadi. Un cinema intimamente, profondamente morale. Piccole scene rivelatrici: per riprendersi, per ricominciare a far rifiorire un po’ di pace, la moglie ha preparato una pasta. Ha usato dei soldi che credeva fossero del marito. E invece erano stati lasciati dallo sconosciuto. Il marito, senza dire una parola, prende la pasta e la butta via. I soldi legati a un peccato, a un crimine, sono macchiati per sempre. Da noi, in occidente, i soldi non hanno padrone.
Che cosa è bello nel film di Farhadi? L’attenzione, il rispetto verso tutti i personaggi: tutti hanno le loro ragioni, tutti sembrano persone e non personaggi. Il senso di sospensione su quello che è veramente accaduto, in casa, quel giorno. La forza del dubbio, che invade il protagonista. La tensione interiore di tutti i personaggi. L’onestà di fondo che tutti i personaggi tendono ad avere: diresti, paradossalmente, persino quando mentono. E quella recitazione, così misurata, con degli scatti di violenza così minimale, che quando scoppiano fanno ancora più impressione. E insieme, tuttavia, c’e’ qualcosa di meno immediato, di più studiato rispetto a Una separazione; forse a causa degli intermezzi in cui vediamo le prove di Morte di un commesso viaggiatore, per quel senso di voluta simmetria tra il “teatro nel cinema” e la vicenda raccontata. Un senso che tra l’altro potrebbe sfuggire a chi non fosse familiare con la piece di Arthur Miller. E forse, in definitiva, di questi inserti non c’era neanche troppo bisogno.
Visita la nostra sezione su Cannes 2016 per restare sempre aggiornato
© RIPRODUZIONE RISERVATA