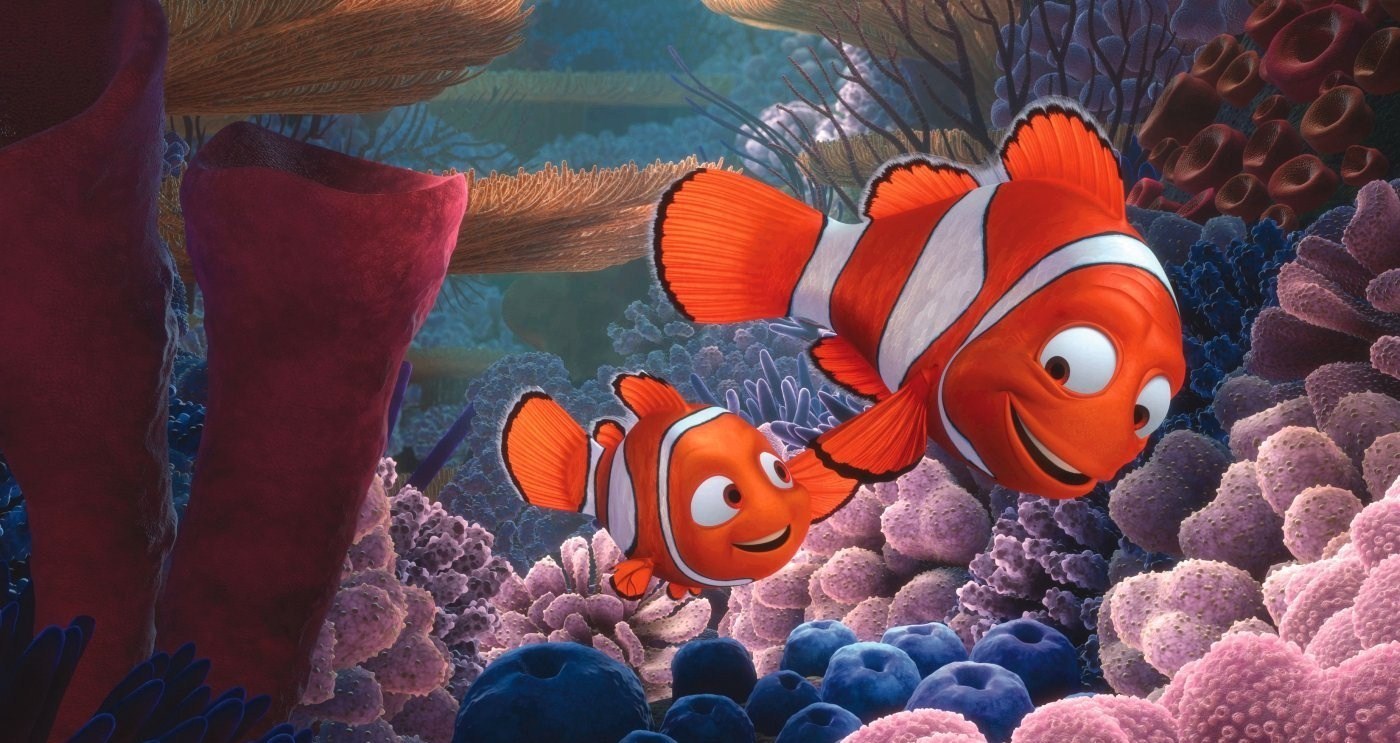Roma, colle Gianicolo, mezzogiorno: il cannone spara il suo colpo a salve sotto la statua di Garibaldi (“Roma o morte”), un coro gregoriano canta sul davanzale della Fontana dell’acqua Paola, che qualcuno usa per rinfrescarsi. Un turista giapponese fotografa l’orizzonte della città dalla terrazza panoramica, fin quando cada a terra privo di sensi (colpo di sole? sindrome di Stendhal?). Poi, stacco: sul tetto di un appartamento con vista sul Colosseo, sotto il neon di una spaventosa insegna Martini, va in scena la festa per i 65 anni di Jep Gambardella (Tony Servillo): ci sono (letteralmente) nani e ballerine in quantità, imprenditori e politici, attricette e sedicenti intellettuali marxiste, più un commediografo fallito (Carlo Verdone) e una ex soubrette “in totale disfacimento psico-fisico” (la resuscitata Serena Grandi, nella performance più masochistica del secolo).
Jep è uno scrittore riciclatosi come colorista per un magazine femminile senza nome, autore di un unico grande romanzo (L’apparato umano) e di un unico grande fallimento (il primo, indimenticato, mai consumato, amore). Un napoletano trasferitosi a Roma con un unico obiettivo, pienamente centrato: diventare il centro della vita mondana della capitale. Non soltanto invitato a tutte le feste, ma “in grado di poterle rovinare” con la sua assenza. In quella mondanità sguazza disincantato, malinconico, feroce e un po’ assonnato: vede il mare della sua adolescenza sul tetto della camera da letto, ed è l’unico paradiso che lo fa addormentare.
Il film finisce qui i suoi scopi, nei primi meravigliosi 40 minuti (forse addirittura prima), e poi avanza per un’altra ora e mezza, di sipario in sipario, per noia e diletto, pleonastico, incompiuto e non compibile, con personaggi che entrano ed escono dalla storia come i moscerini nelle stanze, d’estate, il pomeriggio. C’è la spogliarellista quarantenne che per un po’ conquista Jep con la sua spontaneità coatta (Sabrina Ferilli, la più brava), il vicino di casa silenzioso e ostile che nasconde segreti giganteschi, il cardinale quasi-papà che parla solo di cucina (Roberto Herlitzka), l’illusionista che si allena a far scomparire le giraffe tra le mura millenarie della città (“e se non fosse un trucco, ti pare che alla mia età non mi sarei già fatto sparire io?”), la bambina pittrice-prodigio che vorrebbe soltanto mangiare bignè, il mago del botox un po’ astrologo e un po’ cafone (Massimo Popolizio), la santa di anni 104 (“a vederla la facevo più vecchia”) incartapecorita, serafica, più sveglia e viva di quanto sembri. Ed è forse questo il tratto comune a tutti i personaggi, il ribaltare lo stereotipo sotto il quale si presentano, il riscattare in qualche modo le aspettative dello spettatore, dimostrando la stessa generosa condiscendenza – ma anche curiosità, e simpatia – nel Sorrentino autore e nel suo alter ego Jeb, che sembra conoscere vizi e virtù di tutti, e tutti avere già giudicato e universalmente perdonato. Perfino se stesso.
Il quadro si arricchisce così via via di dettagli, in un processo d’accumulo che potrebbe continuare all’infinito, surreale e grottesco, consapevolmente felliniano, vita non più dolce ma disperata e chiassosa, autoironica, distruttiva, depressa.
Alla fine c’è anche un finale, ed è forse questo il problema più grosso del Sorrentino autore: troppe parole, troppe cose, troppi simboli, la voglia di chiudere un cerchio che non si può chiudere (“ho cercato la grande bellezza ma non l’ho mai trovata”) con una soluzione elementare e consolatoria. Non gli sono mai venuti bene, i finali, e anche nel mezzo si perde sovente. Ma a girare resta un poeta.