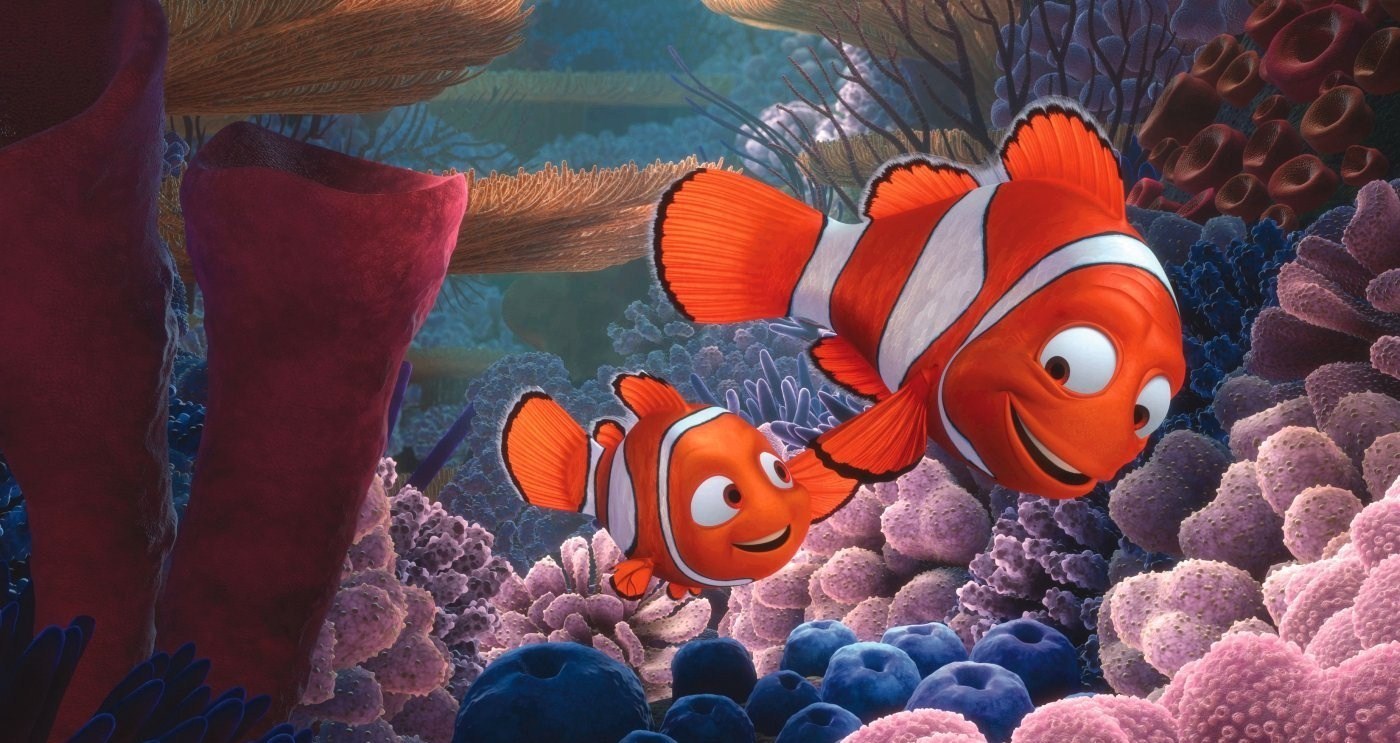Con l’ottavo episodio, Il salvataggio, è appena terminata la seconda stagione di The Mandalorian, la serie Disney+ con la quale la LucasFilm pare stavolta aver messo d’accordo proprio tutti, a cominciare, ovviamente, dai fan del franchise di Star Wars. La nuova trilogia aveva infatti dannatamente faticato a pacificare gli animi degli appassionati più rigorosi, in gran parte delusi da un approccio o troppo calcolato ed ecumenico (Il risveglio della forza) o troppo revisionista (Gli ultimi Jedi) o ancora poco incline ad osare nel tentativo di far quadrare, anche giustamente, i conti (L’ascesa di Skywalker). Tanto che, a distanza di pochi anni, da quei film sembra separarci una voragine temporale già molto ampia.
Jon Favreau, creatore e curatore di The Mandalorian (forse però, data la complessità della macchina produttiva di Star Wars, qualcosa meno di uno showrunner, considerando l’apporto di Kathleen Kennedy e Dave Filoni), ha trovato la giusta misura praticamente in tutto. E in particolare, tra l’altro, in ciò che a J.J. Abrams era riuscito solo in parte: traghettare la mitologia della saga creata da George Lucas nella contemporaneità, trovando anche il polso dei tempi nello sbrogliare la matassa. Intercettando cioè, del racconto audiovisivo odierno, linguaggi, tic, estensioni e ossessioni, come ben evidenziato dal marketing puccioso, a misura tanto di meme e gadget quanto di polemica alimentare sulle uova, di Baby Yoda. Senza convocarli tutti contemporaneamente e ad ogni costo (per carità), ma anche senza affollare troppo il quadro, come a tratti sembravano fare le sorti sul grande schermo di Rey e Kylo Ren. Uccidere i padri va bene, ma poi tocca anche farsi strada, magari sulle proprie gambe.
Se gli ultimi film di Star Wars, pur nella loro godibile ma non costante efficacia di fondo, hanno dato l’impressione di castrare e rendere più asfittico l’universo narrativo della galassia lontana lontana, in The Mandalorian è tutto più giocoso, arioso, libero. Ci si prende meno sul serio, c’è meno polverosità e rigidità nelle dinamiche narrative. La sudditanza nei riguardi del passato familiare di Guerre stellari non si traduce mai in cappi paternalistici forse perché, in fondo, si parla soprattutto d’infanzia. Il racconto si sviluppa più a margine dei flussi principali della storia e alla fine della fiera, come già in Rogue One, questo lavorare a latere più che un limite, settimana dopo settimana e di puntata in puntata, si è rivelato un pregio (così come la possibilità di aspettare e centellinare quei quaranta minuti o più ogni venerdì, balsamo confortante e analogico in tempi di forzato binge watching selvaggio).
Tenendo basse le aspettative della vigilia e lavorando con solerte gusto artigianale, fin dalla prima stagione, The Mandalorian pian piano si è ritagliato una grossa nicchia d’immaginario. Ha trovato un preciso punto d’incontro tra l’economia storica di Star Wars e l’immaginario di una Disney ormai detentrice di una fetta sempre più cospicua degli scenari produttivi e industriali di oggi, sul grande come sul piccolo schermo. Tanto che la differenziazione tra i due formati suona ormai superata (non da oggi) e la seconda stagione di The Mandalorian è perfino – e di gran lunga – più cinematografica della prima, non solo per splendore figurativo ma anche per respiro. Ribadendo così quanto, dopo l’Investor Day disneyano di fine 2020, è ormai inequivocabile: dopo aver portato le logiche della serialità al cinema col Marvel Cinematic Universe, altra sua proprietà, la Casa di Topolino sembra intenzionata a fare viceversa con i prodotti destinati a Disney+, dei quali The Mandalorian verrà ricordato, forse, come il prototipo (questa è la via, come ormai chiaro a tutti, ma il futuro è in compenso ancora tutto da scrivere e studiare).
Della seconda stagione di The Mandalorian Jon Favreau ha diretto solo l’episodio iniziale (e uno dei più standard), come a farsi garante della compattezza granitica e tutta d’un pezzo del protagonista Din Djarin, metonimia di tutta la serie e del suo approccio squadrato ma eclettico. A Lo sceriffo (il nono segmento, esordio della seconda tranche di episodi), sono seguiti tuttavia capitoli capaci di andare molto oltre rispetto alla grammatica da western intergalattico della prima stagione: un sostrato efficacissimo e un usato sicuro sempre valido, come insegna l’operazione geniale fatta da Sergio Leone con La sfida del samurai di Akira Kurosawa, cui si sono aggiunte sequenze d’azione più spettacolari, un’ironia più sorvegliata e un romanticismo commovente, che da sotterraneo che era non si è più vergognato di mostrare cuore e lacrime sotto armature e corazze.
L’episodio in assoluto più riuscito è probabilmente il capitolo 13, La Jedi, scritto e diretto da Dave Filoni, già produttore di The Clone Wars e Star Wars Rebels, con al suo interno alcuni dei più bei dialoghi della storia di Guerre Stellari. Tutto merito del recupero filologico, ma anche vivido e coinvolgente, del personaggio della jedi Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson, che in questa seconda stagione ha trovato il modo di risplendere appieno e di essere all’altezza della sua fama iconica. Ma non hanno deluso nemmeno Il vendicatore di Rick Famuyiwa, il più esaltante nelle coreografie action e negli inseguimenti, e La tragedia di Robert Rodriguez, che attraverso una messa in scena piana e distesa ha saputo valorizzare al meglio la scorza ruvida e la pellaccia del rientrante Boba Fett di Temuera Morrison. La conferma di validi comprimari ha fatto il resto, dalla Cara Dune di Gina Carano al Moff Gideon di un ispirato Giancarlo Esposito, mefistofelico e spassionatamente crudele, che nell’ultimo episodio diretto da Peyton Reed (regista di Ant-Man) è esploso in tutta la sua forza terribile e serafica.
Se gli ultimi film della saga avevano badato a un’organicità più cerebrale (tanto nel fanservice quanto nelle linee narrative di servizio), The Mandalorian sembra aver preferito un’altra direzione, ovviamente più efficace ma non per questo ruffiana. Nemmeno nel bellissimo e per il momento ancora non spoilerabile finale, molto simile per eco e portata a quello di A Rogue One: A Star Wars Story, che anzi è parsa la conclusione più giusta e doverosa possibile: uno schietto e sentimentale approdo di tutto il cospicuo worldbuilding accumulato in precedenza e del rapporto sempre più tenero e sfaccettato tra Mando e Grogu, vero nome di Baby Yoda che abbiamo appreso nel quinto episodio della seconda stagione.
Da un lato un uomo che non ha più mostrato il volto da quando era bambino, e dall’altro un bambino che quel volto troverà il modo di sfiorarlo, accarezzarlo, lambirlo. Mostrando tutta la sua Forza, sepolta sotto i vagiti e l’assenza di parole, in un mondo in cui il silenzio non è altro che coesistenza di ordine e caos, pace forzata dopo la rivoluzione, quiete dopo la tempesta. Quella tra Mando e Grogu è una simbiosi da buddy movie struggente che ha, prima di tutto, il sapore della grande letteratura, della buona vecchia e cara epica; quella zona vergine dell’immaginario in cui la memoria di tutte le cose viventi, un po’ come la Forza di Star Wars, sopperisce al ricordo che si fa più stanco, smarrito, confuso, precario. E allora, per il momento, giù l’elmo, e anche un po’ il cappello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA